L’Acquario
Martedì ho avuto il problema del carburante. Tutte le stazioni di servizio parevano essere state prosciugate nella notte e le indicazioni sul cruscotto lasciavano poche speranze, non sarei arrivato fino al lavoro. A metà tragitto ho invertito il senso di marcia per provarne una che avevo visto sfilare sull’altro lato della carreggiata. Enormi buche piene di acqua grigia rendevano complesse le manovre per accedere alla piazzola.
In coda all’impianto di autolavaggio c’erano tre o quattro carcasse di auto. L’Apocalisse Bianca, come l’avevano battezzata, era arrivata di domenica mattina, giorno di pulizie per molti automobilisti.
Accanto al distributore, c’erano due individui con la barba incolta e un sorriso da canaglia accovacciati su sedie di plastica. Potenzialmente pericolosi. Il problema è che non avevo scelta. Quando sono sceso dall’auto, uno dei due si era già alzato in piedi.
«Desidera il pieno signore? Acqua e olio?»
La colonna self service ha risucchiato rapidamente la mia tessera.
«Vai al lavoro amico?»
«Sì,» ho risposto mentre sganciavo la pistola dalla pompa.
«Hai da mangiare quindi?»
«No.»
«Sì che ce l’hai. Hai una macchina, un lavoro, forse ancora una casa. Ma quanto durerà ancora?»
«Non lo so.»
«Perché non ti licenzi?»
L’odore della benzina pizzicava le narici.
«Dico a te, ciucciacazzi,» mi è venuto sotto. «Perché non ti licenzi? Che senso ha?»
Con la coda dell’occhio ho controllato le sue mani. Erano libere. Si è avvicinato ancora. Con il viso a pochi centimetri dal mio ha scandito la stessa domanda.
«Che. Senso. Ha.»
Ormai sono passati cinque mesi da quella domenica mattina, primo giorno dell’Apocalisse Bianca. Il notiziario a reti unificati continua a ripetere che il peggio è alle spalle. Io di scenari post apocalittici ne ho visti a decine al cinema e devo dire che in molti film non c’erano andati troppo lontano. A ogni modo non si può mai essere veramente preparati a questo.
Una cosa che non mi aspettavo per nulla, per esempio, era che le regole al lavoro rimanessero immutate. Mi pareva automatico che la fine del mondo o, anche più modestamente, il semplice collasso della civiltà che conosciamo, coincidesse con la fine delle alzatacce mattutine e dell’angoscia della timbratrice. Per non parlare dei turni a scalare, dei richiami in campo o dei week end lavorativi. Invece niente. Ciò che poteva essere l’aspetto consolatorio di tutta la vicenda sembra sia andato a farsi benedire. Abbiamo ottenuto qualche concessione sulla flessibilità in entrata, poca roba considerando che il tragitto per raggiungere il posto di lavoro è ogni giorno complicato da nuove incognite. Il peggio è passato? Non sembrerebbe proprio, anche perché le malattie epidemiche sono in fase tutt’altro che regressiva, nuove crepe nel suolo si aprono e quei bagliori bianchi che avevano preceduto il primo boato riappaiono in cielo di tanto in tanto, minacciando di completare l’opera. L’Apocalisse Bianca era durata tre giorni, ne sarebbero bastati un altro paio per far calare il sipario definitivamente.
Dopo aver finito il rifornimento, ho levato le tende più in fretta che potevo. Al mio arrivo in fabbrica, il parcheggio dei dipendenti era vuoto per metà. Solo una sbarra è rimasta in funzione per cui, al varco di ingresso, si era comunque creata una fila di macchine. Il turno di lavoro ha inizio alle 7.30. La tolleranza di dieci minuti è stata portata a venti vista l’eccezionalità della situazione. Nella bacheca sindacale c’è uno scarno comunicato in cui le sigle riunite ringraziano l’azienda per la comprensione e si impegnano a ridiscutere la questione non appena ce ne saranno le condizioni.
Della ditta che gestiva il transfer agli hangar non si sa più nulla. La navetta è spiaggiata a margine del parcheggio con le ruote a terra. Il tragitto, a piedi, l’ho percorso insieme a un motorista prossimo alla pensione. Era uno che aveva sgobbato sul serio nella vita. Camminava come se avesse appena ricevuto una pallonata nello stomaco.
«Ce l’hai il pranzo?» mi ha chiesto.
«No.»
«Neanche io. Troppo pericoloso. Ieri mi hanno fatto scendere dalla macchina e me lo hanno portato via.»
«Dov’è successo?»
«Sotto casa. Erano in tre, uno aveva un martello. Non mi porto più niente dietro.»
Sapevo che stava cercando una scorciatoia per andare in pensione anticipatamente.
«Che ti ha detto l’ufficio personale per lo scivolo?» ho chiesto.
«Che mi danno in culo.»
Il mio ufficio è un container a vetri posizionato in fondo all’hangar, tutti lo chiamano “l’Acquario”.
Come prima cosa, ho analizzato i dati inviati dal controllo produzione. In base alle disposizioni per il razionamento dei consumi di energia, l’utilizzo del monitor è consentito solo nella prima mezz’ora di lavoro. A quanto vedevo, per la settimana in corso il personale risultava dimezzato. Due persone erano morte la settimana scorsa a seguito di infezioni respiratorie, contratte probabilmente dormendo in ripari di fortuna, tre persone erano in ferie. C’erano poi i dispersi, cinque in tutta l’azienda, verso cui si accavallano provvedimenti disciplinari per assenze ingiustificate.
A metà mattinata il capo controllo è piombato nell’Acquario.
«Hai saputo la novità?»
«No.»
«D’ora in avanti si faranno due riunioni di produzione a settimana.»
Non sapevo che dire. Mi stava informando che l’appuntamento più nauseante della settimana sarebbe raddoppiato.
«Si fanno anche di martedì, cioè oggi,» ha proseguito senza pietà per lo sconforto che leggeva nel mio sguardo. «Alle 14.00.»
All’ora di pranzo sono andato in sala fumatori. Di solito non c’è nessuno a quell’ora. Seduto sulla panchina ho trovato invece un quadro commerciale. Ormai mi aveva visto per cui sono entrato lo stesso, sperando che avesse intenzione di fumare e starsene zitto. Come altri del suo reparto, preferiva mischiarsi poco con la manovalanza e in hangar ci metteva piede solo per la pausa sigaretta. Aveva la faccia squadrata, cosce grosse e un completo di marca della taglia sbagliata. Il phisque du role dello scoreggione, a mio parere. Fumava Rothman rosse.
«Come procede la tua commessa?» ha chiesto subito, senza neanche darmi il tempo di accendere. Non solo voleva parlare, voleva parlare di lavoro.
«Siamo intorno al cinquanta percento,» ho sparato, dopo aver tirato la prima boccata. «Dovremmo richiedere qualche avionico in più.»
«Impossibile. Non ce ne sono disponibili.»
«Siamo indietro nelle istallazioni.»
«Fallo presente alla riunione di produzione ma la vedo difficile.»
Accanto aveva la sua borsa portapranzo. Dalla tasca laterale spuntava un kit per lavarsi i denti. Sapevo che era sposato. Mi chiedevo chi gli avesse preparato il pranzo. E se la sua famiglia non trovasse assurdo il perdurare della sua routine lavorativa.
«Stamattina per poco non rimanevo a piedi,» ho detto per tastare il terreno.
Un breve lampo di sdegno ha attraversato il suo sguardo.
«I problemi personali dobbiamo lasciarli fuori da qui,» ha detto spegnendo la sigaretta.
Alla 14.00 sono andato alla riunione di produzione. Quando sono entrato erano già tutti intorno al grande tavolo rettangolare al centro della stanza. Il program manager ci aveva appoggiato i piedi sopra: l’ufficio era il suo, ci teneva a farlo presente.
Il mio proposito per la riunione era quello solito, restare il più possibile in disparte. Il primo a prendere la parola è stato il quality manager. Aveva modificato l’assetto della barba, anche pantaloni e scarpe sembravano nuovi, con velleità giovanili spavalde. Doveva essere reduce da un week end di compere nell’unico centro commerciale ancora in funzione in città. Ha incentrato il suo intervento sul fatto che il momento era difficile ma che né l’incertezza economica né la carenza di personale dovevano abbassare i nostri standard qualitativi. Le procedure andavano rispettate fino in fondo. Lui era a disposizione per qualsiasi chiarimento.
In realtà ogniqualvolta mi fosse capitato di andare nel suo ufficio a chiedere chiarimenti si era dimostrato tutt’altro che disponibile. Dava sempre l’impressione di uno in terapia per il controllo della rabbia.
Successivamente ha preso la parola il capo dell’ingegneria. Si era deciso di procedere in senso orario. Questo significava che mi restava qualche minuto per organizzare un mezzo discorso. Ho scartabellato con discrezione il bloc-notes che avevo con me e ho rintracciato gli appunti portati a una riunione di un paio di mesi prima. Variando qualche dato qui e lì sarebbero andati bene. Rinfrancato mi sono messo ad ascoltare quello che aveva da dire il capo ingegneria. Mi sono permesso anche di annuire un paio di volte. Poi è accaduta una cosa inaspettata. Il tizio ha cominciato a evidenziare l’impossibilità di proseguire il lavoro come se niente fosse, soprattutto con la consapevolezza che lo stipendio non arriva da quattro mesi e che dai clienti non è lecito aspettarsi garanzia sui pagamenti. «Fingiamo di ignorare che alcuni clienti non ci sono neanche più,» ha detto. Gli altri hanno controbattuto con rabbia. «Non sei pagato per fare ragionamenti finanziari, pensa a fare il tuo lavoro» ha inveito il quadro commerciale che avevo incrociato nella sala fumatori.
«Non sono pagato proprio,» ha risposto il capo ingegneria.
Il quadro commerciale ha sferrato un plateale applauso e la riunione è stata dichiarata sciolta.
Prima di congedarci, il program manager, ci ha messo al corrente che per far fronte alla mancanza di personale erano stati assunti alcuni stagisti.
Mercoledì, cioè ieri, mi sono ammalato.
Per la verità già martedì sera avvertivo dei brividi di freddo, ma avevo provato a ignorarli. Il dottore di famiglia è morto due mesi fa, dopo una lunga agonia. Sul suo studio compare un cartello del ministero della salute che annuncia a breve l’assegnazione di un nuovo medico. Ma per il momento non ho ricevuto alcuna comunicazione in merito. Non c’è modo di ottenere certificati di malattia se non recandosi in un ospedale, dove la situazione infettiva è talmente fuori controllo da sconsigliarne l’accesso. Non restava che sperare fosse solo un po’ di influenza.
“Alla catastrofe non deve seguire un decadimento morale, coloro che agiscono senza regole abbandonando il proprio posto di lavoro sono gli individualisti di prima che ora cercano di sopraffare l’altro. L’unica via per lasciarci alle spalle l’Apocalisse Bianca è riprendere dal punto in cui ci aveva condotto l’intera esperienza dell’umanità.” In auto, mentre andavo al lavoro, ho ascoltato il giornale radio alle prese con i soliti messaggi. In sostanza quello che ribadivano da mesi, senza tregua e senza contradditori, è che non c’erano spazi per riorganizzare un bel niente senza riciclare lo stesso modello lavorativo. Neanche ora che il crollo di tenuta del sistema civile era evidente e che probabilmente moriremo tutti. “Non è il momento di cercare scappatoie, ma di rimboccarsi le maniche”
All’altezza della stazione di servizio ho rivisto i brutti ceffi del giorno prima. Avevano portato le sedie sul ciglio della strada e posizionato in mezzo alla carreggiata un cartone con su scritto “CHE SENSO HA?”. Ho dovuto guidare contromano sull’altra corsia per evitarlo.
La strada dal parcheggio fino all’hangar l’ho percorsa di nuovo insieme al motorista prossimo alla pensione.
«Non ti senti bene?» mi ha chiesto
«No, ho un po’ di mal di testa.»
«Hai la febbre?»
«Non credo.»
«Dai, sarà solo un po’ di influenza,» ha detto, poi si è piegato a terra fingendo di allacciarsi una scarpa per mettersi a distanza di sicurezza. Non me la sono sentita di intralciare il suo piano per cui ho proseguito a camminare senza aspettarlo.
A metà mattina i sintomi sono peggiorati. Mentre ingollavo un’aspirina, ha bussato alla porta a vetri dell’Acquario lo stagista assegnatomi. Aveva i capelli ricci e una faccia che grondava smania di fare colpo.
«Ho sempre avuto una passione per gli elicotteri bimotore,» ha puntualizzato dopo le presentazioni di rito, «questi hanno le pale controrotanti vero?».
Non ho risposto. Non sono riuscito neanche a guardarlo negli occhi. Ho solo provato un enorme pena per l’idea di passare il resto della giornata in sua compagnia, per le mie condizioni di salute e per le nuove eruzioni solari che avevo visto in cielo all’uscita da casa.
Giovedì, oggi.
«Chi pensa di emanciparsi dal lavoro produttivo non troverà la libertà che crede, ma sarà causa di…»
Sto molto male. Questa mattina ho provato a contattare l’ufficio del personale ma ho trovato la segreteria con la registrazione di uno dei messaggi trasmessi a rotazione sulle radio. Ho messo giù prima che terminasse. Mi sono vestito e sono uscito, nonostante i dolori.
Ho trascorso gran parte della mattinata tampinato dello stagista riccio. Un collega mi ha messo in guardia dicendo che è il nipote del program manager, ma che non si deve sapere. Abbiamo passato in rassegna le procedure di accettazione delle parti provenienti dai fornitori e i criteri per lo stivaggio al magazzino. Si è mostrato molto interessato alla gestione informatica dei vari processi, nonostante il server di riferimento non risulti più raggiungibile e, con tutta probabilità, è irrimediabilmente compromesso. Ormai riportiamo tutto su registri cartacei. Mi è sembrato un po’ infastidito dalla superficialità con cui ho trattato alcuni passaggi. Ora è con gli altri stagisti a un briefing nell’ufficio della qualità. Non credo che mi troverà al suo ritorno. Sto pensando di uscire prima e andare in ospedale. Finisco di scrivere queste poche righe e vado a parlarne con il capo controllo. Non avrei mai pensato di affidare le mie memorie a una cassettiera da ufficio, con tanto di rotelle. Sono le undici e cinquanta. Le lamiere dell’hangar fremono, assediate dal vento.
Daniele De Serto è nato e vive a Roma, ha pubblicato racconti su varie riviste tra cui Portland Review, Fiction Southeast, Linus, Granta Italia, Litro Magazine, Gravel, The Saint Ann’s Review, Cheap Pop, ‘Tina, Colla, Cadillac, L’inquieto, Inutile, Verde, Pastrengo.


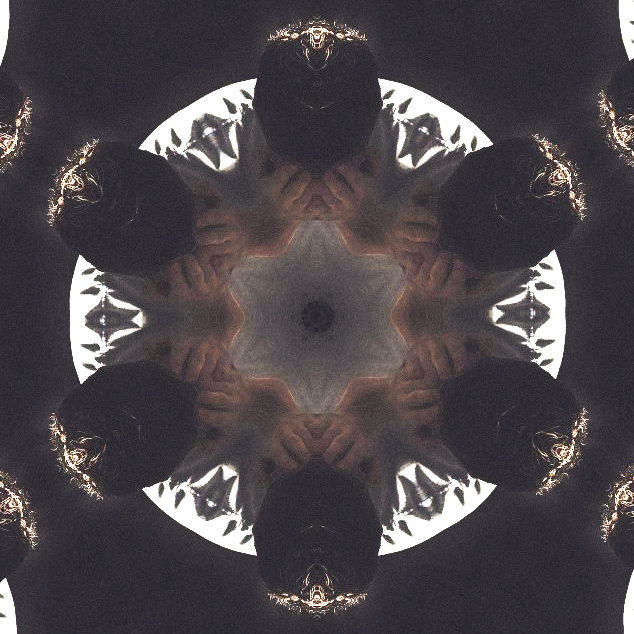


1 Commento
Unisciti alla discussione per dirci la tua
[…] L’acquario di Daniele De Serto su Split (Pidgin Edizioni) […]