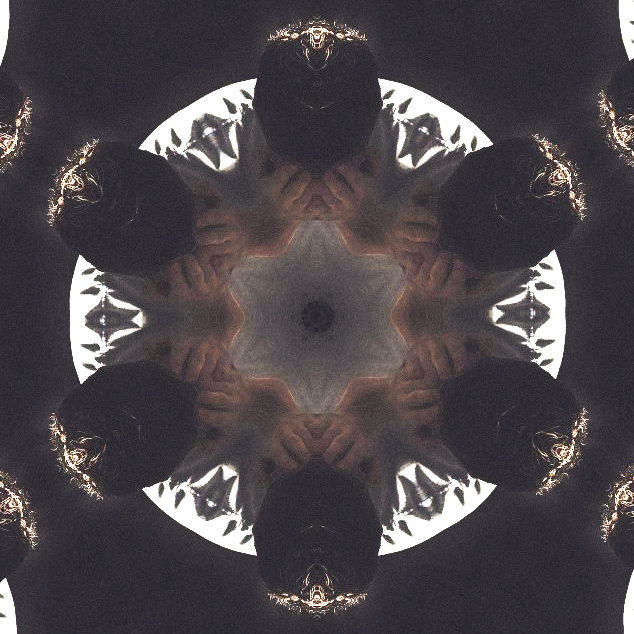La Venere dei Miraggi
“Venere dei Miraggi” – Scultura anatomica in cera, Giovanni Battista Aldovino,
165 cm, aa. 1780-1782.
I
Se gli uomini vedessero ciò che sta sotto la pelle […],
la sola vista delle donne sarebbe per loro nauseabonda:
la grazia femminile è solo muco, sangue, umore, fiele.
Sant’Oddone da Cluny
I miei pensieri galleggiano come animali morti nella formalina. Stranamente, l’unica cosa a cui riesco a pensare sono le facce di quelli che mi conoscevano prima di tutta questa storia della Venere. Facce sorprese che, interrogate, rispondono come si conviene. Certificano tutti i miei buongiorno e buonasera che sbadato ho offerto in chissà quali pianerottoli o incroci. Sento le voci sgraziate e becere del vicino, del barista tatuato, della padrona di casa, del rettore: aveva una faccia buona il professore, com’è possibile?
Capisco il vostro sconcerto e in qualche modo lo perdono. Ma che spreco di tempo quei pettegolezzi, quell’andare a rovistare nel mio passato e voler identificare un motivo, una scusa, un presentimento di quello che è successo. Ve lo dico io e fidatevi: tutto è iniziato quando ho rivisto la faccia di Lapo Petri, amico dimenticato d’infanzia e ritrovato per caso in un bar d’Oltrarno, il cui nome taccio per galanteria, benché, ormai, chi volesse sapere, sa.
Ecco la mia confessione. Vi sarà utile immaginare una mattina qualunque a Firenze, città grigia quasi per statuto, ma quel giorno insolitamente brillante come per un presagio.
II
Lapo Petri non mi sembra invecchiato di una virgola. Mi è difficile sovrapporre l’immagine sbiadita che ho mantenuto di lui, con quella sorprendente che ho di fronte. L’avrei destinato alla calvizie prima dei quaranta, all’ospedale, alla strada, alle toppe sui gomiti, alle frustrazioni di un matrimonio, o alle punture della solitudine, quando il cameriere sparecchia il tavolo per due e si rimane da soli, a fissare la punta della forchetta.
Al sole del primissimo pomeriggio torturavamo le lucertole sulla piastra della fontanella del nostro paese. Lapo, allora ragazzo timido e un po’ codardo, seguiva con timore e curiosità le crude e laboriose operazioni che riservavo a quelle creature. Mi stava dietro la spalla, e chiudeva gli occhi ogni volta che il coltellino svizzero si spingeva a fondo nello stomaco di quelle bestiole, facendole contorcere come un pelucco di paglia quando prende fuoco. Giochi di ragazzi.
Oggi lo vedo sereno. Peggio: sorridente. A cosa sarà dovuta questa gioia improponibile? Le ragioni di una vita piena mi si riducono in polvere. La loro banalità, la loro contabilità spicciola, è riproducibile sulle dita di una mano. Dovrei andare per esclusione.
L’infanzia su di me, con tutto il suo corredo di spensieratezza e nostalgia, non ha più molta presa. Lapo, che sembra balzato di nuovo nella mia vita, a cavallo di quel periodo morto e sepolto, mi sorprende per un ritorno che mi viene da giudicare non solo improvviso, ma anche inutile.
Quand’è stata l’ultima volta che l’ho visto? Non lo ricordo.
Ma l’amico ritrovato sorride, come a riconsegnarmi le briglie di una vita in comune. Ci beviamo qualcosa? Che prendi, caffè? Preferisci un tè?
Vado a passo lento verso il barista, che mi propone anche lui un sorriso da manifesto. Lo specchio alle sue spalle mi conferma la stessa faccia di sempre. Il ricordo di quell’ultima volta non riesco a scovarlo nelle pieghe del viso, nelle rughe e nelle occhiaie profonde. Se c’è, è qualcosa di confuso e a brandelli, sfilacciato come un vestito tarmato. Ma forse a non esserci è la totalità del mondo, in tutto questo apparire e svanire che è un flusso continuo e ininterrotto dal passato remoto, al presente, al futuro. E io e lui, adesso, galleggiamo nel nulla, e in questo stesso nulla, girandomi, chiedo di nuovo: Scusa Lapo, hai detto tè o caffè?
Poco dopo, siamo venuti al dunque. Lapo sgrana i suoi occhi di un verde scaduto. Setaccia a grandi linee la sua biografia. Mi aggiorna. Fuori dall’enorme finestrone del bar la luce si abbatte sui tetti delle case quasi a volerle bruciare.
Quest’ansia da cena di classe mi annebbia ancora di più i pensieri e le parole che vorrei dire non si articolano come dovrebbero.
Mi passa un biglietto dai lati stondati, carta di pregio, filigrana in bella vista, su cui è impresso un nome. Lo struscia sul tavolino, portandolo con indice e medio sulla superficie verso di me finché gli è concesso dai termini consuetudinari del gesto, forse un poco più a lungo.
«Tenebris Mirabilia?»
«Il mio negozietto,» dice arrivando alla fine del suo riepilogo.
«Passa uno di questi giorni. Ho una cosa da farti vedere.»
Ridiamo per l’aria da agente segreto che ha assunto. Forse entrambi pensiamo ai giochi terribili della nostra infanzia, come fossimo ancora complici, ancora ragazzi. Ci accordiamo per il giorno, e quando mi porto la mano al portafogli chiamando con un gesto il cameriere, Lapo scatta in piedi, mi dice: lascia fare, e come un gatto inselvatichito tira fuori una banconota con cui paga allegro il conto. Non giochiamo a insistere.
«Allora… martedì a mezzogiorno».
«Martedì a mezzogiorno» confermo.
La voce di Lapo si diluisce nel soffuso e indistinto acciottolarsi delle tazzine dietro il bancone e nelle chiacchiere fumose della clientela.
Mezz’ora dopo sono schiena al muro ad angolo con piazza del Carmine e, come un condannato alla fucilazione, attendo che il mio personalissimo carnefice si decida a risolvere questa attesa a fior di nervi. C’è, nell’aria di via Santo Spirito, un impasto di suoni, lo scalpitare di marmitte e voci che tramortiscono la mattina cittadina, l’odore fresco del pane e dell’asfalto. Con venti minuti di ritardo Mariastella Aldi si muove verso di me a passo di danza, con tutto il suo armamentario capace di stupire le platee, intabarrata nella sua tipica sciarpa di un fucsia acceso, le ginocchia scoperte, le calze di lana.
Frequentare una studentessa è un cliché. Vale poco ogni tipo di giustificazione, che comunque sgrano come un rosario ogni volta che temo la soffiata in dipartimento. Tutto, ogni preoccupazione, ogni timore, si nebulizza nel momento stesso in cui Mariastella si tira dietro al collo la sciarpa calante, e il suo profumo va ad anestetizzare quelle parti del cervello dedicate alle preoccupazioni. Non sono così vecchio e lei non segue neanche più i miei corsi… ma che importa, mi dico, che importa! È primavera e la luce sfavilla al di là dalle case: tutto contribuisce al miracolo.
Quando mi dà un piccolo bacio sulle labbra, sento il suo profumo di pelle appena lavata e l’umidità del suo respiro che mi carezza i baffi, come fa il vento in alcune ballate del nord ai fili d’erba verdissima. Quelle robe irlandesi che a lei, pare, piacciano tanto. Mi allontano dalla sua bocca, solo per dettagliarla meglio. Per assicurarmi che il resto del mondo sia ancora tutto in piedi, che non si sia sciolto come un sogno di sapone, e non per accertarmi che nessuno ci abbia visto, come lei sembra pensare aggrottando le sopracciglia, scocciata.
«Martedì sera suonano i miei amici,» dice.
Ma non seguono inviti.
III
Martedì a mezzogiorno.
Lapo mi accoglie come farebbe un buon diavolo. Osservo in lui una stanchezza che non avevo notato l’altro giorno. Non so bene perché ho accettato un invito così patetico. Forse volevo solo scoprire il fondo di quella sua serenità. Si scusa per le scartoffie sulla scrivania, poi mi indica una porta e mi dice di precederlo, emozionato quanto un pilota al suo primo volo.
Il magazzino in cui entriamo è grande due volte il negozio. Al suo interno, il rigoroso e ben pensato ordine degli oggetti esposti nella sala principale non è trapelato neanche un poco. Sembra la soffitta di una vecchia nonna in cui i ricordi di mille vite si affastellano e dialogano tra loro, in un discorso fatto di silenzio e di polvere.
Cammino attraverso un caos di busti greco-romani che si spalleggiano con vecchi automi, cassettoni settecenteschi sui quali campeggiano Nautilus di varie dimensioni, coralli enormi incastonati in scatole di legno pregiato e strumenti di non so che genere; una vecchia volpe impagliata congelata nel gesto di avvertire un pericolo, corna di svariati animali, fissati a delle plance o semplicemente appoggiati qua e là. Vecchi libri, strani armamenti, scudi araldici di famiglie dimenticate, busti in marmo di personaggi a me sconosciuti, una sciabola arrugginita, il ritratto di una vecchia dal volto severo e quello di un gentiluomo con un gatto violaceo sul grembo, strani meccanismi sotto campane di vetro, fragili marchingegni di chissà quale utilità…
Attraversiamo la stanza fino a raggiungere un’altra porticina dietro la quale salgono piccole scale. “Ma quant’è grande questo fondo?” penso facendo due calcoli veloci sul possibile canone d’affitto. Lapo fraintende i miei pensieri e mi rassicura.
«Perdona tutta questa segretezza da carbonari, ma ciò che tengo qua sopra è veramente qualcosa di eccezionale. Vedrai.»
«Niente di illegale, vero?»
La risata di Lapo mi arriva da dietro le orecchie e mi calma in uno strano modo.
«Aspetta solo un secondo…»
Il piccolo antro in cui entriamo a turno è una saletta in cui solo un grosso oggetto ci sta comodo, al centro esatto della stanza. Una piccola finestrella garantisce l’unica fonte di luce che basta esclusivamente per decifrare il grosso ingombro. Per il resto è vuoto e le pareti sono spoglie. Lapo mi supera e si mette tra me e la sorpresa.
«Eccola!» esclama con gesto da prestidigitatore.
Una statua di cera sprofonda su un enorme cuscino di seta, retto a sua volta da un tavolino con delle grosse e scure zampe a forma di testa di leone. Cerco di mettere a fuoco, di tirare le somme dello stupore.
«Questa è la mia Venere anatomica.»
Eccola: la statua di una donna stesa come su un letto di piacere, un braccio piegato voluttuosamente sopra le testa, l’altro steso lungo il corpo. Le ginocchia sono impercettibilmente flesse, le gambe si stendono e i piedi si sfiorano appena, una caviglia leggermente posata sullo stinco. Ma è il busto la vera meraviglia. Queste veneri, mi spiega Lapo, venivano fabbricate per non sporcarsi le mani in tempi in cui lo studio dell’anatomia umana doveva spesso ricorrere alla pratica della dissezione dei cadaveri, con tutto il bagaglio di problemi etici e pratici che si portava dietro un affare del genere, e come tentativo artistico ed estetico di glorificare il rapporto tra Uomo e Creatore. Questi ideali di Bellezza erano stupendi fuori e perfetti dentro. Per questo il busto della Venere è scoperto come un’infiorescenza, una rosa di carne, e i suoi organi interni sono esposti in bella vista. Il ventre e il tronco si squarciano così che si possa godere del suo corredo d’intestini e polmoni. Alla luce tenue della finestrella, la sua milza brilla come ricoperta di brina. La Venere offre allo sguardo il suo grosso fegato scuro. Come fosse caduto l’ultimo dei pudori e io fossi il più assoluto dei voyeur, la Venere mi dona la sua nudità più intensa.
Mi ci perdo.
I capelli sono lucenti, si adagiano intorno alla testa come un drappo regale; gli occhi azzurri sembrano ancora dotati di sguardo, sembrano vivi e mi guardano di là dalle palpebre appena socchiuse. C’è qualcosa di erotico nel trasporto con cui questa statua inanimata si appoggia sventrata sull’enorme cuscino. Qualcosa che eccita una parte segreta di me a cui non so dare nome.
«Questa è l’unica Venere anatomica rimasta dell’Aldovino.» Lapo punta il suo lunghissimo indice come un direttore d’orchestra e con la stessa solerzia scandisce il tempo del mio disorientamento, indicando qua e là quell’affare dalle fattezze di donna, ma che donna non è.
«Nota la perizia dei particolari, la maestria della lavorazione del modello, la perfezione della cera…»
Solo lo scampanellare della porta al piano di sotto lo distoglie da quel compito che deve proprio amare, tanto il trasporto con cui il suo volto si trasfigura dal godimento.
«Scusami, torno subito, ti lascio solo con lei due minuti». Poi sembra pensare se dire o meno qualcosa in più. Quindi dice: «Mi raccomando.»
Mi ritrovo così nel silenzio di quella piccola stanza, a condividere l’angusto spazio con un ammasso di cera inanimato per il quale il mio amico deve di sicuro avere speso un patrimonio, non so neanche quanto legalmente. Osservo con attenzione la scultura e non riesco a credere ai miei occhi. Ricorda quelle statue della Specola, penso, andando a fatica a ricercare una memoria lattiginosa dei tempi delle gite con la scuola ai musei della città. Questa brilla però di una patina diversa, qualcosa sotto la sua superficie mi chiama a gran voce. L’incarnato della pelle non è spento, e di certo tutto sembra fuorché cera. La pelle di questa Venere pare fatta di un materiale sconosciuto. Qualcosa di vivo. Sento un calore sciogliersi dietro la fronte, devo distogliere un primo ineducato impulso di toccarla. Meno male che resisto, perché Lapo si materializza alle mie spalle senza che neanche me ne accorga. Quanto sono stato a fissarla?
«Scusami ancora, un cliente. Allora, che ne pensi?»
«No, cioè sì… è indubbiamente un gran pezzo,» farfuglio cercando di nascondere un principio di affanno. Mentre ansimo sottilmente, muovo le mani in aria, a distrarre l’amico.
«Si vede una certa… maestria. Un lavoro di fino. Chi hai detto che… chi l’ha fatta?»
«Giovanni Battista Aldovino.»
«Non credo di averlo mai sentito.»
«Mi sorprenderebbe il contrario. Da parte sua solo eccellenza e mistero. Egittologo, maestro alchemico, naturalista dalle grandi capacità. Tante le voci, poche le fonti. Di sicuro c’è che è stato un grande ceroplasta. Guarda, vedi i capelli? Vedi come brillano? E le unghie?»
«Sembrano vere.»
«Sono vere.»
«Che vuoi dire?»
«Alcune parti della Venere appartenevano a Donna Lucrezia Gargante, amante dell’Aldovino, alla cui prematura scomparsa il Maestro ne immortalò la bellezza in quest’opera: La Venere dei Miraggi. O almeno così dicono.»
«Sono vivi?» chiedo avvicinandomi ai capelli dorati, lo sguardo pronto a catturare ogni sfumatura. Ho gli occhi di un gufo che ha notato il topo nella sterpaglia.
«Sì, lo sono stati.»
Balbetto qualcosa. Un rivolo di sudore scava una trincea all’altezza della tempia destra.
«E quindi… anche…»
«Anche i peli.»
Sento ancora l’affanno mentre lo sguardo rimbalza dal pube della Venere alla finestrella, poi come un principio di febbre oscura la vista. Sento l’uccello cominciare a gonfiarsi contro i pantaloni. Cosa mi succede?
Mi ricompongo in tempo per i saluti. Lapo mi stringe la mano sudata e io mi posso dare in pasto alle stradine che si trovano fuori al suo negozio. Il vento serale soffia su di me, attacca il sudore alla pelle e mi permette di pensare al giovane corpo di Mariastella, che non è fatto di cera ma di carne. Che non è morto ma è vivo. Che mi aspetta a un certo punto della notte.
Mariastella balla tra la colonna e il gruppo, stretto all’angolo del locale. La poca luce a neon le colora di blu la pelle mentre snoda un corpo architettato solo per dimostrare quanto si poteva fare in termini di bellezza con muscoli, ossa, peli, organi e quant’altro. È uno splendore. Sento il primo sorso dell’intruglio analcolico, che mi ha preparato un barista dai baffi ridicoli, scendermi attraverso il petto. Il suo coinquilino la saluta abbracciandola con sicurezza.
La bellezza è qualcosa di fragile, è uno specchio di luce che a guardarlo troppo si frantuma. Così non fosse, se non concorresse l’abitudine, o lo sfiorire naturale delle cose, il suo volto ci sarebbe insopportabile. Una bellezza che non scade è insostenibile. Mentre guardo Mariastella muovere i fianchi e flirtare candidamente con l’amico musicista, mi chiedo, sull’onda di pensieri del genere, cosa starà mai facendo Lapo con la sua Venere a quest’ora. Rido mentre me lo immagino pettinare i suoi lunghissimi capelli d’oro come una vecchia zia, con quella sua faccia soddisfatta e le borse sotto gli occhi, mentre io qui assisto in disarmo alla vita che non fa altro che vivere. Rido, ma poi qualcosa mi accalora le tempie e mi trovo a stringere la morsa dei molari. Rido. E un po’ lo invidio.
Mariastella si muove verso di me, la fronte imperlata di sudore e in leggero affanno. Com’è stanca, niente a che vedere con l’elegante e atroce sofferenza della Venere. Penso che potrei rivedere Lapo e la sua opera, per potergli dare un giudizio meno frettoloso e più professionale. In fin dei conti non mi sembra di essermi comportato da amico con Lapo, né tantomeno da professionista. Lapo si aspettava forse da me un giudizio accademico, e io non sono stato all’altezza.
«Tu non bere?» mi chiede Mariastella con un falso accento tedesco, che usa per rendersi più interessante.
«Sto bevendo.»
«Dico una birra. Una bevuta, che ne so.»
«Per ora sono a posto così.»
«Molto malen,» si lamenta e scivola via a ballare ancora.
Due ore dopo, al termine di una lunga noia, fuori dal locale, decidiamo di fare due passi.
Firenze si srotola sotto i nostri piedi in un silenzio che ci rende complici, come dei criminali prima del grande colpo. Passiamo per via dei Calzaiuoli priva dei turisti giornalieri, solo un paio di studenti che vanno a rintanarsi in qualche casa d’altri. Le immagini pubblicitarie dei negozi chiusi propongono donne bellissime, immortalate nelle posizioni più scomode. Mariastella ride cercando di ricrearne qualcuna in mezzo alla strada. C’è un vento leggero, non troppo da infastidire, ma abbastanza da camminare stretti l’uno all’altro.
Arrivati al mio palazzo, saliamo all’ultimo piano. Entriamo in casa che ancora siamo avvinghiati e così procediamo fino alla mia camera, dove un letto con lenzuola color malva è pronto ad accoglierci. Mariastella si rialza, dà un’occhiata veloce alla mia stanza. Formula dei primi giudizi dietro la fronte corrugata che non esprime in alcun modo, mentre si spoglia lentamente e setaccia con lo sguardo la mia libreria, il mio armadio, i miei oggetti personali. Poi si avvicina e quasi inciampa nei vestiti caduti a terra. Ridiamo della sua goffaggine e cadiamo di nuovo. Poco dopo vengo senza problemi, ma al culmine dello sforzo il volto sacro della Venere dei Miraggi, lo sguardo inerme di donna Lucrezia, mi appare in un lampo di piacere.
Il giorno dopo mi sveglio presto. Mariastella dorme ancora accanto a me, per la prima volta da quando ci frequentiamo. Osservo le sue labbra semichiuse in cui il respiro trapela appena, i micromovimenti di questa cosa viva che è la ragazza che ho desiderato e avuto, sepolta dalle lenzuola come una statua antica, ritrovata nel deserto da archeologi operosi.
E adesso che si fa?
Una fitta all’altezza del fianco fa nascere un pensiero orribile. Vorrei che Mariastella si svegliasse di colpo e come per magia si rivestisse. Così, in un battito di ciglia. Vorrei che uscisse da casa mia. Che sparisse dalla mia vita. Vorrei non vederla mai più.
Che rivelazione terribile: sono quel tipo d’uomo? Com’è possibile che questo mio desiderio di possederla, una volta soddisfatto, si sia dileguato così in fretta, scappato dalla finestra come un debitore con l’usuraio alla porta? Scaccio il pensiero con un bacio sulla fronte di Mariastella che si sveglia e mi dà il buongiorno.
«Facciamo colazione insieme?» le chiedo. Sono quasi fiero di aver rigettato quei primi disumani istinti.
«Ho lezione.»
Indosso una faccia tragica, ma sento che una piccolissima particella della mia mente vibra, nel fondo di me, di un sollievo vergognoso.
IV
«Le manca la parola,» mi sussurra Lapo di fronte alla Venere, prima di scendere le scale e tornare alle sue faccende. Nelle ultime settimane sono passato dal negozio più spesso di quante scuse sono riuscito a trovare per nascondergli la verità. Prima è stato tutto un parlottare dei bei vecchi tempi. Poi un giro di caffè e discorsi sull’arte, sull’estetica, sulle infinite capacità della luce quando sfiora una superficie delicata e quant’altro. Infine, Lapo ha accolto la mia richiesta di poter passare dei minuti da solo con la Venere, “per contemplarne la perfezione.” Dopo aver condito il tutto con una serie di complimenti per l’affare, alla fine più che sinceri, Lapo accetta la bizzarra richiesta e si mette al lavoro nella sala principale, mentre io mi siedo nella semioscurità con la Venere. Passiamo dei momenti incredibili, io e lei da soli. Chissà cosa pensavi nel tempo di tua vita mortale, Donna Lucrezia. E cosa penseresti adesso, che nonostante tutto sei ancora al mondo, in una forma del tutto bizzarra e impensata, cristallizzata dall’amore di un genio. La guardo nei suoi occhi luminosi e una calma assoluta si fa spazio in me. Dal fondo delle scale sento spostare delle cose, riconosco Lapo parlottare con una serie di clienti che scandiscono i vari pomeriggi.
A volte io e Lapo ci scambiamo solo dei saluti e dei sorrisi, e vado direttamente per le scalette, come fossi un idraulico di fiducia che sa bene dove stanno i contatori dell’acqua.
Nel frattempo, Mariastella ha ripreso la sua vita di sempre e del professore probabilmente si è già dimenticata. In dipartimento non la vedo neanche più, forse mi evita o forse sono io che inconsciamente fuggo a ogni sguardo. Perché le mie giornate ora sono piene di una luce stupenda, come non lo sono mai state. Sono riempite dalla Venere e sono spese tutte a creare i nostri momenti di silenzi reciproci e di contemplazione, di intese a cui non serve la parola, di fiducia in una bellezza che non è di questo mondo, ma che la Venere sa richiamare, ovunque la vada a cercare. La bellezza di Donna Gargante non può scadere, perché è impossibile possederla. E questo l’ho imparato a caro prezzo, nel momento in cui ho provato a toccarla.
V
All’ultimo non ce l’ho fatta. Non mi sono trattenuto. Sentivo che qualcosa in me gridava affinché la toccassi, mi stringessi a lei, la facessi finalmente mia. Ho capito a mie spese che non si può stare a guardare un monumento a una bellezza oltremondana, aliena quanto si vuole, ma presente e viva, senza mai allungare la mano. Forse un santo potrebbe. Io, a quanto pare, non posso.
Nel momento stesso in cui le mie labbra toccano le sue è come se tutta la bellezza del mondo passasse attraverso una feritoia, e quella feritoia sono proprio io, con tutta la mia miseria e il mio peccato. E non trattengo niente, lascio solo che le cose fluiscano. Ma non dura più di un secondo, un respiro, una bazzecola di tempo, perché senza che me ne accorga le mie mani, poggiate sul tavolo dalle zampe leonine, gravano di un peso insostenibile per due corpi uno sopra l’altro, e io e la Venere cadiamo nel nostro stesso abbandono e soprattutto dritti sullo stesso pavimento.
Lo schianto richiama Lapo, che vola le scale solo per trovare me e la Venere a terra. Ancora oggi un brivido mi scuote se ripenso alla scena. Eppure non saprei descrivere l’immagine dell’amico che non trova le parole, che s’infiamma e urla, la poderosa vena sul collo che palpita impazzita. Che mi colpisce, mi sputa addosso, mi offende. Che si avventa su di me e mi scuote e cerca di gettarmi giù dalle scale. La sua faccia stravolta non è mai stata più lontana da quella di ragazzino dallo sguardo timido. Deve essere andata più o meno così, con me che non provo neanche a dare spiegazioni, che balbetto qualcosa di incomprensibile, che giuro di ripagare l’inestimabile, che cerco di riacciuffare per i capelli la mia mente, nel frattempo rintanata dalle parti del trauma. Di quale peccato mi sono macchiato! Come poter recuperare a una perdita del genere! Come poter convivere con l’immensa colpa di aver distrutto l’unica porta conosciuta per una dimensione in cui la bellezza non ha mai fine! Due grosse lacrime rigano il mio volto e il presente diventa d’un tratto un qualcosa di umido e indistinto.
Il percorso a ritroso dalla sala della Venere mi fa sentire un verme e dura un’infinità. Sento addosso il peso degli sguardi di tutte quelle anticaglie. Passo tra i bronzi, le porcellane cinesi, le ambre, le giade, gli avori di animali estinti. Vengo giudicato in silenzio da un sarcofago, da una pelle di tigre penzolante, da un’armatura giapponese. Procedo come sull’asse del patibolo in quella camera delle meraviglie.
L’amico mi mette alla porta e vengo riconsegnato in disarmo alla strada, alla città vuota, al mondo senza più luci.
Una settimana. Il tempo che ci vuole affinché mi rimetta. Tempo di dedizione al lavoro, di scartoffie ed esami, ore svuotate di senso in cui ho trascinato, in giornate inutili e nell’insonnia notturna, una vita sterile. Un messaggio di Mariastella cerca inconsapevolmente di riportarmi alla vita: Cosa tu fare, professoren?
Tre ore dopo, il corpo nudo di Mariastella si muove ondeggiando, tra le mie nuove lenzuola color malva. Ma ben presto qualcosa nel disegno complessivo delle cose si inceppa o, per lo meno, affiora un problema di cui fino ad allora non avevo colto la portata.
Una lama di luce dei lampioni filtra dalla finestra incidendo leggera il volto di Mariastella. I suoi occhi sono chiusi, la bocca è leggermente piegata in una smorfia di dolore; l’espressione del suo godimento è un’immagine di pura sofferenza. Mentre facciamo l’amore, capisco che qualcosa non va. Quando la penetro, i suoi lamenti dipingono sul volto il ritratto del piacere più banale.
Dov’è la beatitudine della Venere, quel volto trasfigurato dalla grazia nonostante l’orrore scoperto, il fiore di carne viva del ventre? Dov’è il mistero di quel sorriso inestimabile? Non posso accettare l’immagine di Mariastella. Non risponde più ai meccanismi che scatenarono in me la passione, il desiderio, la voglia di avere qualcuno. Non la voglio così, troppo umana. La scanso violentemente tanto che lei si volta come per stare a un gioco. Non capisce, fatica a leggermi dentro.
«Ma sei scemo?»
Un’intenzione precisa è esplosa dentro di me, forte e luminosa. Mi chiedo come mai il mio corpo non appaia trasparente, splendente come quello di un santo, lucido come una radiografia. I timpani pulsano. Sono tamburi di guerra. Tum, tum, tum. Mariastella non scampa all’incomprensione nemmeno quando ritorno dalla cucina, coltello alla mano. Tum, tum, tum. I suoi primi dubbi sembrano dissolversi solo nel momento in cui il suo ventre, come un padrone di casa all’ospite di riguardo, si offre alla lama fredda e insensibile.
Il suo corpo adesso è immobile, la mia mano si muove come se fosse stata creata per eseguire le complesse operazioni che sta per compiere. Per un attimo mi sembra di essere a lezione, e di star spiegando a un gruppo di ventenni annoiati e stronzi i principi base della meraviglia. Muovo il coltello nello stomaco e pratico una serie d’incisioni fino a che non riesco a portare alla luce il suo personalissimo corredo di cuore e polmoni, di intestino, di viscere. Lavoro per l’intera notte al mio capolavoro, il sudore mi cade copioso dalla fronte e si mischia al sangue, alle lenzuola adesso color porpora scuro. Il tum, tum, tum si affievolisce.
Alla fine mi accorgo che è giorno, e ritrovo un grammo di lucidità, la quantità necessaria per lasciare che i miei occhi infossati posino lo sguardo sul volto di Mariastella. Solo allora capisco l’orrore: il suo volto è deturpato da un’espressione raccapricciante, la bocca è contorta, gli occhi sono come un vetro appannato, i suoi capelli biondi sono sfatti e sparsi come dei filacci sporchi e insensati, il sangue le ha confuso i lineamenti. Non assomiglia per niente alla Venere. La mia sconfitta è totale. È solo una ragazza morta qualunque, e non c’è bellezza nel fondo di due occhi morti e vuoti che ti guardano sbarrati senza più vedere.
Rimango così, nudo alla finestra, mentre l’alba mi investe dolcemente. Il tepore del primo sole sulla pelle. A terra il coltello. Ovunque il sangue. Sul letto la ragazza. Sul vetro il mio respiro. In quest’alba terribile e meravigliosa, i segni della fine.
Filippo Cerri vive in provincia, ad Albinia, in faccia al Monte Argentario. Ha vissuto a Firenze e Bologna. Lavora in un hotel, scrive durante i turni di sera. Secondaria, almeno in termini di stabilità economica, ma non meno importante la sua attività di videomaker. Ha pubblicato racconti in due antologie curate da Effequ.