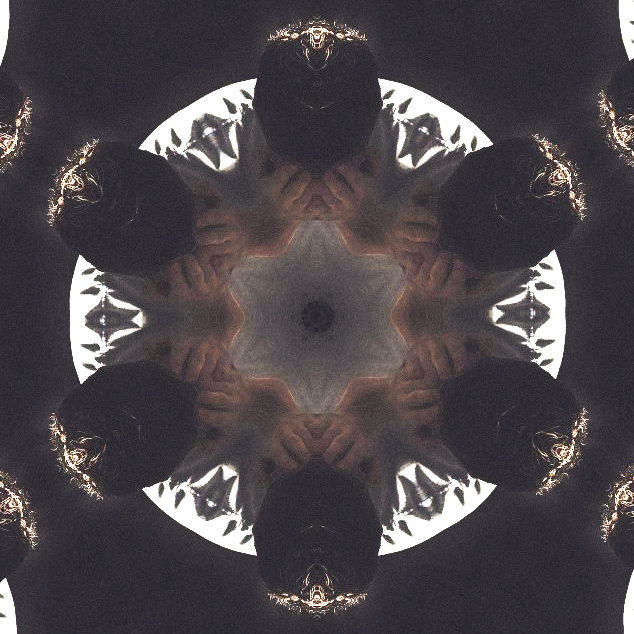Come in una commedia romantica
Quando tornava a casa la sera tardi ne lasciava uno vicino alla porta. Qualche settimana dopo il risultato era una montagnola informe di oggetti che franavano lungo quel parquet che al calpestio suonava vuoto. Ma se sbirciavi nei buchi che si erano formati tra le assi potevi scorgere una colonna di formiche che in fila indiana edificava nell’oscurità una colonia sotterranea, una cattedrale capovolta dove la vita era regolata da ritmi serrati, sempre in moto e al sicuro dall’uomo.
Devi aprire questa porta. Dico sul serio.
Mi sento soffocare.
All’inizio ammonticchiava oggetti che evocavano inequivocabilmente esperienze trascorse insieme: i biglietti della prima di un film locale che aveva ricevuto il plauso della critica internazionale; il conto della cena per festeggiare il loro primo anniversario; i biglietti motivazionali che attaccavano con la calamita al frigorifero; la playlist masterizzata delle canzoni che raccontavano la loro relazione; il collare col campanellino del loro primo animale domestico – un gatto che tagliò la corda dopo una sola settimana, liberandosi e spruzzando urina su tutti i suoi giochi; un autoscatto stampato su carta lucida che li ritraeva sorridenti in una spiaggia mezza deserta nell’estate di diversi anni prima. Roba da rom-com americana, roba banale vista e rivista. Dal giradischi in salotto echeggiava la voce rassicurante di Bob: Don’t think twice, it’s all right.
Ti prego amore. Mi comporterò bene, posso migliorare.
Ho capito che ho sbagliato.
Hai ragione, noi due ci apparteniamo.
C’è qualcosa di beffardo nel constatare quanto poco di materiale condividiamo con le persone che amiamo: il mutuo cointestato, i mobili comprati a prezzo ridotto nella grande distribuzione, le ciotole per l’insalata o i calici da vino sono banali catalizzatori di discussioni meno banali, di calcoli e divisioni su chi deve pagare cosa, di rancore represso per chi investe economicamente di più nella relazione. L’abbonamento mensile a Netflix e a Spotify, il cinese o la pizza a domicilio, la tassa sui rifiuti, le bollette del gas – che ironicamente deve pagare chi a casa trascorre meno tempo perché è sempre a lavoro – sono un coacervo di servizi che sfora le tre cifre mensili e che diventa benzina nel fuoco represso di un senti-dobbiamo-affrontare-questa-cosa pronto a esplodere.
Ti prego sii razionale. Possiamo risolvere questa cosa insieme. Fammi uscire.
È trascorso solo un paio di settimane quando gli oggetti che raccontavano il loro amore sono già stati tutti ammonticchiati sul pavimento. Pensava fossero di più. Inizia a riporne giù degli altri, quelli che nelle rom-com non fanno apparizione. Capelli incastrati nello scarico, un rasoio abbandonato in doccia ostruito dai peli, fazzoletti usati appiattiti e dimenticati sotto qualche cuscino, suolette logore appartenenti a vecchie paia di scarpe, calzini bucati o spaiati. Oggetti che non raccontano più una storia comune, ma che documentano il passaggio di un singolo corpo in assenza dell’altro.
Nel primo atto c’erano stati gli amanti e una fame cannibale. Nel secondo atto la scenografia cambiava: A. si trovava da un lato della parete e O. dall’altro, ad A. veniva consegnata in mano una chiave e O. poteva solo sbirciare dalla serratura. Ad A. spettava la libertà mentre O. si vedeva murare ancora in vita. A. con quegli oggetti stava costruendo un museo, O. osservava l’organizzazione di un cimitero.
Giuro che butto giù questa porta sei una merda umana ti odio ti detesto spero che tu muoia quando esco ti ammazzo con le mie mani non sfidarmi.
Al cospetto di un cadavere deceduto in circostanze non chiare si deve effettuare l’autopsia. La verità non è mai univoca, esistono più prospettive sullo stesso fatto osservabile. Un’autopsia dell’affetto può avere inizio con uno sguardo inedito sui medesimi oggetti: il biglietto di un film al cinema dove per la prima volta A. nota che agli angoli della bocca di O. fanno capolino dei rimasugli biancastri di cibo ormai essiccato e, mentre trattiene nervosamente un conato, O. interpreta lo sguardo fisso sulle sue labbra come manifestazione di desiderio e istintivamente si china in avanti il conto della cena di anniversario che O. aveva pagato per poi rinfacciarlo per tutta la serata; i messaggi motivazionali che rivelavano un’irrequieta nevrosi, una continua tensione verso una maggiore performatività lavorativa-sociale-culturale-economica; il collare del gatto che aveva dato clandestinamente in adozione per scongiurare qualsiasi possibilità di una famiglia. l’autoscatto in spiaggia sorridenti, dopo un viaggio di due ore in auto trascorso in un rabbioso silenzio. L’inventario non è uno spazio letterario, non si presta ad ambiguità o riscritture e in quei cinquanta metri quadri si doveva fare una scelta, a favore di una visione luminosa o di una abissale.
Ti prego ti supplico fammi uscire io qui non voglio morirci non ce la posso fare ti prego aiutami non è vita questa ma dove cazzo sei io non ce la faccio più voglio andare avanti non capisci dobbiamo conoscere gente nuova la nostra vita deve continuare sì è vero ti amavo va bene ma era tanto tempo fa ti odio mi fai schifo bruttamerda.
Chiude gli occhi come aveva imparato al corso di meditazione, e immagina gli oggetti dell’inventario fondersi in un’unica massa informe e grottesca, dove i fazzoletti gonfi di muco contaminano i biglietti del cinema e il collarino del gatto si chiude perfettamente intorno al collo di una suola bucata. Una massa pulsante senza più storia, dove i fluidi organico-corporei si mescolano alle memorie conservate come sotto formaldeide, esposte a una fiera campionaria diventando non più i loro oggetti e i loro ricordi ma quelli rivendicabili da chiunque altro: una storia banale uguale a tutte le altre perché in ogni relazione tutto è una reiterazione di un preciso diagramma dove ogni atto di presunta spontaneità segue precise coordinate che hanno già inscenato tutte le persone venute prima di te. Isolando i suoni esterni ignora i pugni contro la porta i calci e le grida IO TI AMMAZZO e con gli occhi ancora chiusi immagina di passarsi tra le dita un fiammifero mentre si chiede se nella forza distruttiva del fuoco ci si apra più a una liberazione o a una condanna, e mentre passa sempre più velocemente la capocchia del fiammifero lungo il dorso della mano immagina le pareti tutte intorno a lei bruciare, tremando sismicamente prima di ripiegarsi su se stesse e bruciando anche le formiche in panico mentre crollano le loro architetture capovolte seppellendole vive intrappolandole per sempre mentre tutto questo accade brucia anche l’uomo che amava con la loro storia ridotta in pezzi scomposta e reincarnata in decine di oggetti senza vita brucia il tempo dell’adorazione e quello dell’orrore quello dei sussurri e delle grida dei baci e dei morsi brucia il loro inventario comune con la loro storia materiale e immateriale e solo nel fuoco finalmente non sembra uguale a tutte le altre e in fondo lui gliel’aveva sempre detto che aveva paura quando si spegneva la luce e tutto era buio e poi erano poche le rom-com che finivano così.
Sara Deon nasce nel ’95 nel trevigiano. Ora vive a Padova dove si sta laureando in lingue e letterature. Collabora con l’Indiependente, ed è co-fondatrice del collettivo L’Altrosessuale e del progetto editoriale Andergraund Rivista.