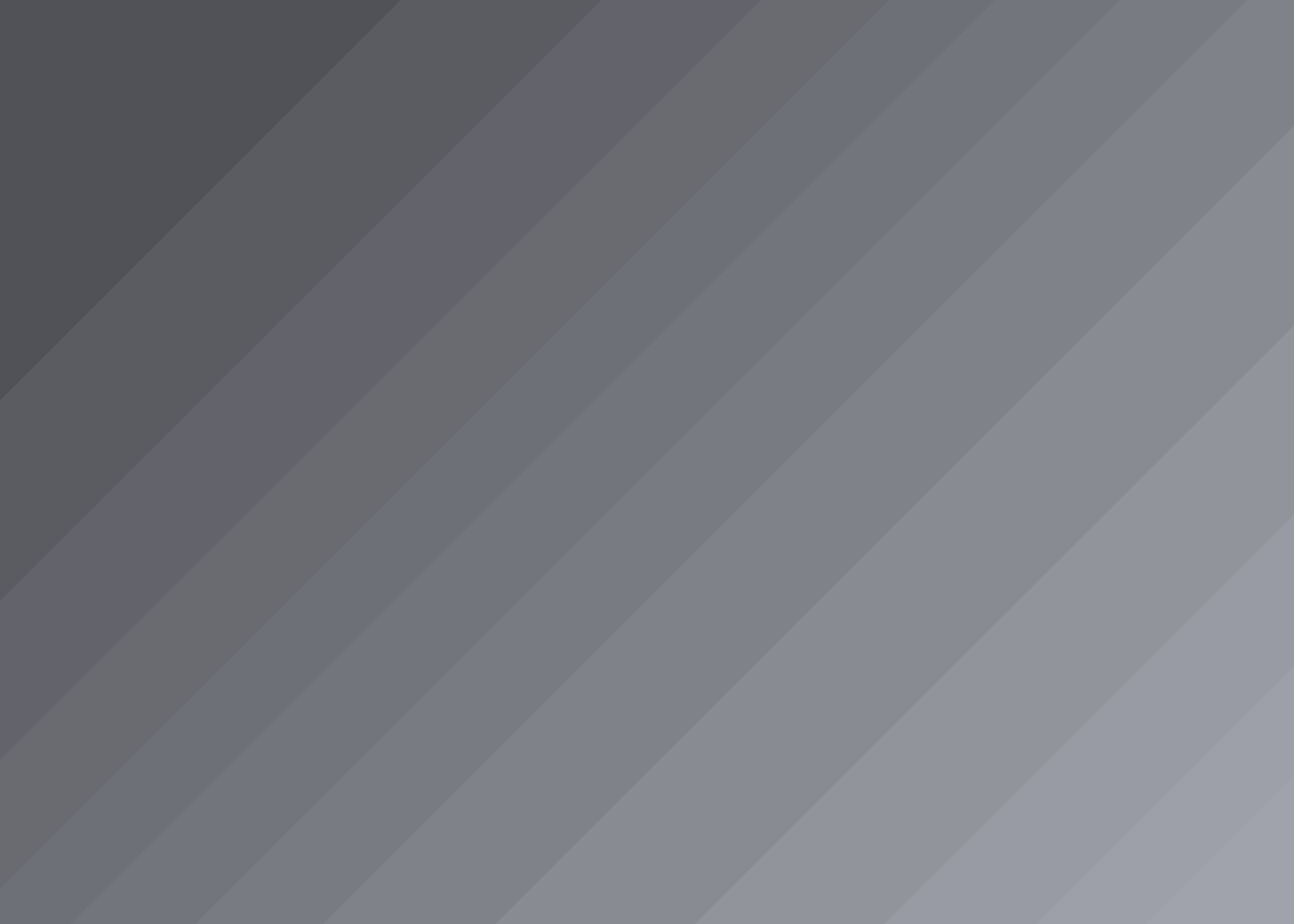Fare pace con il sangue
(Fotografie di Sara Lorusso)
Sono cresciuta in una famiglia ad alta percentuale maschile: tre maschi e due femmine, poi a un certo punto sono rimasta sola, la separazione dei miei mi ha portata forzatamente a essere l’unica femmina dentro una casa piena di caos e totale incomprensione. Per tantissimo tempo mi sono sentita trascurata, non capita, riempivo pagine del mio diario per descrivere quella convivenza forzata come un campo di concentramento in cui io costituivo la minoranza. Sicuramente esageravo, ma il senso di incomprensione era palese e risuonava in casa come un’eco perenne. Mio padre non ha avuto occhi di riguardo per nessuno, non ha monitorato le nostre crescite e i nostri bisogni che cambiavano: è stato equamente indifferente senza fare alcun tipo di discriminazione di genere. Inevitabilmente però, ogni mia evoluzione era un tabù innominabile. La prima volta che ho avuto a che fare con il sangue ero a casa di mia madre, uno di quei fortunati fine settimana che le spettavano. Il weekend con lei era costituito da pasti sfarzosi, farciti, che potessero condensare in 48 ore tutto quello che era mancato nel resto della settimana. Non sapevo neanche cosa mi fosse accaduto, le spiegazioni sul ciclo e le mestruazioni si erano perse tra la separazione e i trasferimenti. Chiamai mia madre in bagno chiedendole cose stesse succedendo, temendo il peggio. Lei si affacciò in quel minuscolo bagno rettangolare con una di quelle vecchie porte a soffietto, e mai come in quella domenica mattina io ringraziai il cielo, un’entità senza nome, che mi avesse fatto avere il menarca in un luogo sicuro, dove potessi essere aiutata, soccorsa ed educata.
Da quel momento in poi i miei ricordi in relazione al sangue sono stati per un periodo dolorosi: il terrore dell’assorbente messo male, i primi crampi a scuola, il ciclo che arriva in anticipo e ti coglie alla sprovvista mentale e soprattutto materiale, lasciandoti incollata a un termosifone con il sangue che ti sporca mentre speri che qualcuno venga a prenderti – raramente qualcuno arrivava. Dopo questo breve periodo, già alle medie i miei ricordi legati al sangue iniziano a sgretolarsi. Facevo ginnastica più di tutte, più di tutti, affermavo che a me il ciclo non dava mai problemi, non capivo le mie compagne che venivano debilitate fisicamente e mentalmente da quei cinque giorni di mestruazioni.
Nel corso degli anni è diventata la mia virtù, l’unico tassello fortunato in un mare di sfortune che si erano attaccate alla mia persona e delle quali non riuscivo a liberarmi. Ero sola, non avevo molti amici, non sapevo parlare con i ragazzi, non avevo soldi, la mia situazione famigliare era instabile, ero sempre sovrappeso e presa in giro. Però non soffrivo il ciclo, ero stata graziata almeno in quello.
Sfoggiavo questa grazia come se fosse la mia più grande qualità, mi piaceva ammettere di essere forte, così temprata dal dolore da sfuggire a quell’appuntamento fisso con la sofferenza.
Non ho mai tenuto traccia del mio ciclo, non ho mai monitorato nulla che lo riguardasse. Quando veniva, veniva, tanto io non me ne accorgevo, lo ignoravo come si ignorano le persone che ti fanno così pena da non meritare la tua attenzione.
Ho iniziato a interessarmene solo nel periodo in cui temevo costantemente di essere incinta, quando ogni primo approccio sembrava assicurarmi una gravidanza. Era un controllo inutile, non sapendo di quanti giorni fosse il mio ciclo, se fosse irregolare, se qualche volta ritardasse oppure no. Ero al liceo, ero ancora sola, non condividevo con le mie rarissime amiche nulla che riguardasse il mio corpo, il sesso, i ragazzi e le paure di aver fatto qualcosa di sbagliato.
Me ne stavo chiusa in camera, in silenzio tombale, a guardarmi e a cercare di capire se l’errore fosse già visibile, a come potervi rimediare.
Dopo qualche giorno il sangue arrivava, noncurante delle mie paure e delle mie attese, perché sapeva che io non mi interessavo mai di lui e dei suoi tempi. Mi graziava e spariva. Finiti i giorni della paura tornavo a ignorarlo, non mi ripromettevo mai di avere più cura di lui e di me stessa, continuavo a relazionarmici con fare distaccato, opportunistico.
Ho iniziato a convincermi di non voler avere a che fare con il mio sangue, perché avevo il terrore di rientrare negli stereotipi. Più del sangue, più del dolore, avevo paura di rientrare nei preconcetti che gravitano attorno al ciclo femminile, a quello che siamo e che diventiamo durante “quei giorni”. Sono stata disgustata e annoiata per anni dalle donne che giustificano il cattivo umore con il ciclo, dagli uomini che ci scherniscono e zittiscono chiedendoci se non siano “le nostre cose” a farci alterare. Non volevo stare dentro le stereotipo, non volevo neanche alimentarlo ammettendo qualcosa come la sindrome premestruale. Volevo che il sangue fluisse via e non mi definisse mai.
Qualche anno fa, provai a donare il sangue, scoprii di non poterlo fare perché non ne ho abbastanza neanche per me. Ho passato più tempo nel reparto di ematologia che in qualsiasi altro luogo, e iniziavo a trovarmi bene in quel reparto pieno di anziani silenziosi. Passati circa sei mesi di esami e controlli, capii di avere una piastrinopenia autoimmune, una malattia caratterizzata dalla drastica riduzione del numero di piastrine, decimate dal sistema immunitario stesso. Ero nello studio della dottoressa, una donna minuta dal viso giovane che aveva un nome per cognome, quindi non riuscii mai a capire come dovessi chiamarla; lei iniziò a spiegare a me e a mia madre cosa comportasse una malattia del genere, soffermandosi sul fatto che avrei dovuto monitorare il mio ciclo con particolare riguardo, di modo da riuscire a intercettare un’eventuale emorragia. Aggiunse che, se la malattia fosse stata recidiva, avrei dovuto tenerne conto nel caso in cui avessi voluto avere un figlio. Avevo ventun anni ed ero un po’ meno sola di prima, continuavo a non saperci provare con i ragazzi e non c’era la reale possibilità che restassi incinta, eppure rimasi terrorizzata. Dalle emorragie, dal dover pensare preventivamente a una gravidanza, doverla calcolare e dover controllare il sangue.
Dopo parecchi mesi di cortisone e cure per rialzare queste piastrine, complici una relazione vagamente duratura e una maggiore emancipazione personale – anche economica – iniziai a prendere la pillola, incalzata dalla dottoressa stessa, che la suggeriva per tenere traccia chirurgica del ciclo . Anche in questo caso non notai mai alcun cambiamento in me: aumento di peso, sbalzi umorali, acne e tutte quelle cose che le donne e ragazze nella mia vita dicevano sarebbero capitate insieme alla pillola. Io mi sentivo invincibile, mi sentivo immune agli stereotipi, volevo sconfiggerli urlando al mondo che il mio corpo non veniva toccato da quelle credenze sessiste.
Ricordo quell’inverno come il periodo in cui piansi fino a scavarmi il viso e a eliminare la grana della mia pelle, eppure non diedi mai la colpa alla pillola.
A un certo punto non ne avevo più bisogno, non volevo spendere altri soldi, quindi la misi da parte senza chiedere niente a nessuno e senza informarmi se esistessero controindicazioni particolari. La eliminai come l’avevo introdotta, e tornai al mio caotico ciclo, forse mai irregolare, bensì mai considerato. Qualche volta, consapevole della mia noncuranza, ho scaricato una di quelle app che monitorano il ciclo al posto tuo. Tu non devi fare molto: la scarichi, segni il giorno in cui le mestruazioni iniziano, quello in cui finiscono, e lei calcola quando dovrebbero arrivarti il mese dopo. Magia, avanguardia pura al servizio della mia pigrizia. Mi capitò di non aggiornarla per un anno intero, letteralmente un anno, e quando finalmente la aprii di nuovo c’era un bollino rosa acceso a indicare che non avevo le mestruazioni da 362 giorni. Scoppiai a ridere pensando alla negligenza dell’app, che in tutto quel tempo non mi aveva mai cercato per chiedermi se fossi viva o meno, o se non stessi per caso covando un bambino da dodici mesi.
Qualche settimana fa mi sono messa a dieta. Tutto il cortisone ingerito non ha alzato solo le piastrine, ma anche il numero che definisce il mio peso. Così come non ho mai monitorato il sangue che perdo, non ho mai monitorato neanche il cibo che ingerisco: forse per me il controllo è un segno di debolezza, vuol dire accettare che nel mio corpo ci sia qualcosa che meriti la mia premura.
Senza volerlo, misurando il cibo ho iniziato anche a osservare cosa mi accade quando si avvicina il sangue. Ero arrivata a credere di essere un’eccezione, qualcosa di non conforme, ma ci sono stati tre giorni in cui sono stata affamata e nervosa e ho placato la tensione con un ritaglio microscopico di cioccolato extra fondente per il quale chiederò perdono al mio nutrizionista. Ci sono stati due giorni di picchi depressivi nei quali ho dubitato di ogni amicizia e persona al mio fianco ora e nel passato; ho sedato la tristezza dormendo più del dovuto e standomene in disparte, evitando reazioni incontrollate. C’è stato un giorno di lenta e piacevole ripresa in cui mi aspettavo da un momento all’altro il grande momento e poi, una mattina, senza troppi dolori ed entrate di scena tragiche e sfarzose, è arrivato il sangue.
Questo è un pensiero sul sangue che non mi sarei mai aspettata di articolare. Nonostante io sia una donna e debba averci a che fare da quando ho circa dodici anni, non avevo mai realmente approfondito la conoscenza con questo fenomeno che mensilmente mi viene a far visita e prende il nome di mestruazioni. Non me ne sono mai vergognata, ne ho sempre parlato con tranquillità davanti ad amici e colleghi uomini, ma non volevo ammettere e accettare che quei cinque giorni di sangue potessero influire anche sui giorni che li precedono e seguono. Credevo che dargli spazio mi avrebbe indebolito e avrebbe minato la considerazione che gli altri hanno di me e delle mie azioni. Non volevo che nella mia persona il sangue fosse visibile, ma ora mi scorre dentro e riesco a sentirlo.
Elisa Lipari è un’illustratrice conosciuta con lo pseudonimo Lipsteria e ha co fondato TUTTE Collective, collettivo femminista di illustratrici e grafiche. Scrive su L’indiependente, The Vision e Il Tascabile. È autrice della newsletter e podcast Masafuera.
Sara Lorusso è una fotografa e artista visiva nata a Bologna nel 1995. Sin da piccola affascinata dalla natura e dalle creature che la popolano, osservava le piante crescere lentamente. Studia fotografia a Bologna, dove si laurea all’accademia di Belle Arti e successivamente lavora tra Bologna, Milano ed ovunque la sua macchina fotografica la porti. Attraverso l’uso della fotografia analogica dialoga con il suo corpo e quello degli altri in un modo molto intimo e personale, difficile da descrivere a parole. https://saralorusso.com/