La moglie di Villon
(Traduzione dal giapponese di Stefano Pirone)
I
Mi svegliai al suono della porta d’ingresso che si apriva, ma non mi alzai. Era senza dubbio mio marito che tornava a casa ubriaco in piena notte.
Accese la luce nella camera a fianco e, respirando pesantemente, sembrava cercare qualcosa rovistando nei cassetti della scrivania o della libreria. Poco dopo sentii un tonfo, come se si fosse seduto di peso sui tatami. Quindi rimase solo il suono del suo respiro, roco e affannato. Non capendo cosa stesse facendo, gli dissi da sdraiata:
«Bentornato. Hai già mangiato? Ci sono delle polpette di riso nella credenza.»
«No, grazie,» rispose con insolita gentilezza. Poi chiese: «Come sta il ragazzo? Ha ancora la febbre?»
Anche questa domanda fu insolita. Il bimbo quell’anno aveva compiuto quattro anni, ma, sarà per colpa della malnutrizione, dell’alcolismo del padre o di una qualche malattia, il suo corpo era più piccolo persino di quello di un bambino di due anni. Camminava in modo instabile e il più che riusciva a dire erano versi come “uhm uhm” o “noo noo”. Mi chiedevo se non fosse ritardato. Quando una volta lo portai ai bagni pubblici, sollevandolo nudo e guardando il suo corpo minuscolo e penosamente magro, mi intristii e scoppiai a piangere davanti a tutti. E poi aveva sempre mal di pancia o la febbre e mio marito, il più delle volte, non riusciva a starsene calmo a casa. Quando, presa dalla preoccupazione che il bambino fosse malato, dicevo a mio marito «Al bimbo gli è salita la febbre,» lui mi rispondeva semplicemente «Ah, davvero? Forse è meglio che lo porti da un dottore,» poi indossava la giacca invernale e se ne andava di fretta non si sa dove. Anche se avessi voluto portare il bambino da un medico, non ne avrei avuto i soldi. Non potevo far altro che coricarmi insieme a lui e accarezzargli in silenzio la testa.
Tuttavia, quella notte, per chissà quale motivo, mio marito aveva stranamente chiesto con gentilezza “Come sta il ragazzo?” Più che esserne felice, ebbi un brivido alla schiena per uno spaventoso presentimento. Non potendo dire altro, restai in silenzio, e per un po’ l’unico suono che si udiva era il suo respiro pesante.
«È permesso?» Una sottile voce di donna provenne dall’ingresso. Il mio corpo ebbe un sussulto, come se mi avessero buttato addosso dell’acqua gelida.
«È permesso, signor Ōtani?» Questa volta il tono di voce era un po’ acuto. Nello stesso istante sentii la porta d’ingresso che si apriva.
«Signor Ōtani! È in casa?» Si sentiva chiaramente che era una voce adirata. Allora mio marito andò all’ingresso:
«Cosa c’è?» Rispose con tono intontito, come esitante.
«Come sarebbe a dire “cosa c’è?”» disse la donna, abbassando il volume della voce: «C’è che lei, con una bella casa come questa, va in giro a rubare. Ecco cosa c’è! La smetta con questi brutti scherzi e ce li restituisca. Altrimenti la denuncio subito alla polizia.»
«Ma cosa dice? Non dica impertinenze! Voi non potete venire qua. Andatevene! Altrimenti sarò io a denunciare voi.»
In quel momento, si udì la voce di un altro uomo:
«Maestro, lei ha proprio un bel coraggio. “Voi non potete venire qua”? Mi lascia basito. Stavolta è diverso. Rubare i soldi delle case altrui… non c’è da scherzare. Non sa quante ce ne ha fatte passare finora. Ciononostante, una cosa così meschina nel pieno della notte… Maestro, mi ha proprio deluso.»
«È un ricatto,» disse mio marito con tono impetuoso, ma la voce gli tremava. «È un’estorsione. Andatevene! Se avete delle lamentele, le sentirò domani.»
«Sta dicendo delle cose gravi, maestro. Lei è proprio un mascalzone vaccinato. A questo punto, non ci resta altro da fare che chiamare la polizia.»
C’era un odio così profondo in quelle parole che ebbi la pelle d’oca su tutto il corpo.
«Fate come vi pare!» La voce di mio marito era ormai stridula e dava una sensazione di vuoto.
Mi alzai dal letto, mi coprii con la camicia da notte, andai nell’ingresso e salutai i due ospiti.
«Salve.»
«Ah, lei è la moglie?» L’uomo dalla faccia rotonda, che avrà avuto più di cinquant’anni e che indossava un cappotto lungo fino alle ginocchia, si volse verso di me senza sorridere e salutò con un cenno della testa.
La donna avrà avuto più o meno quarant’anni: magra, piccola e dall’aspetto curato.
«Ci scusi per l’ora,» disse la donna, che scostò lo scialle e salutò con un inchino, anche lei senza sorridere.
In quel momento, mio marito si infilò rapidamente i geta1 e fece per scappare fuori.
«Non farlo scappare!»
L’uomo lo afferrò per un braccio e i due per un attimo lottarono strattonandosi.
«Lasciami o ti accoltello!» Nella mano destra di mio marito risplendeva un coltello a serramanico. Quel coltello era un oggetto prezioso per mio marito, il quale lo conservava gelosamente nel cassetto della sua scrivania. Era quello, quindi, ciò che cercava quando pareva stesse rovistando nei cassetti, appena rientrato a casa. Senza dubbio aveva previsto che sarebbe successo tutto ciò, aveva trovato il coltello e se lo era infilato in tasca.
L’uomo si tirò indietro. In quell’istante mio marito agitò le maniche del cappotto come un grosso corvo e saltò fuori di casa.
«Ladro!» Urlò l’uomo a gran voce e fece per inseguirlo fuori, ma io scesi a piedi nudi sul terreno sporco e lo trattenni abbracciandolo.
«Si fermi. Nessuno dei due deve ferirsi. Ci penso io a sistemare le cose.» Appena parlai, la donna disse:
«È vero, caro. È un pazzo con un coltello. Non sa quel che fa.»
«Dannazione! Chiamo la polizia. Non posso più permetterglielo,» mormorò l’uomo guardando indistintamente in direzione dell’oscurità all’esterno; tuttavia, il suo corpo intero sembrò improvvisamente perdere le forze.
«Vi chiedo scusa. Prego, accomodatevi. Raccontatemi cosa è successo per favore,» dissi e, salito il gradino all’ingresso, mi accovacciai. «Forse posso occuparmi io di sistemare la faccenda. Prego, accomodatevi. Scusate la sporcizia.»
I due ospiti si guardarono in viso, annuirono leggermente e poi l’uomo riassunse la situazione:
«Qualsiasi cosa ci dirà, le nostre intenzioni sono già decise. Tuttavia, la mettiamo a corrente dei dettagli.»
«Sì, prego. Accomodatevi. Fate con comodo.»
«No, preferirei non trattenermi troppo,» disse l’uomo, togliendosi il cappotto.
«Per favore, si tenga il cappotto. Sul serio, fa freddo. In casa non abbiamo neanche un fuocherello.»
«Beh, allora, con permesso.»
Prima l’uomo poi la donna entrarono nella stanza di mio marito. Tatami consumati, shōji stracciati, muri sporchi, fusuma con la carta divelta e con gli assi in vista, la scrivania e la libreria in un angolo. E per di più, la libreria era vuota. I due rimasero senza fiato davanti a un paesaggio tanto desolato.
Offrendo loro dei cuscini lisi col cotone che traboccava, dissi:
«I tatami sono sporchi. Prego, prendete questi,» e mi inchinai di nuovo.
«È la prima volta che ci incontriamo. Mio marito deve avervi creato tanti problemi. Per qualsiasi cosa abbia fatto stanotte e per il comportamento spaventoso di prima, non ci sono parole sufficienti per chiedervi perdono. Ha un temperamento particolare,» iniziai a parlare, ma mi si strinsero le parole in gola e scoppiai a piangere.
«Signora. Mi scusi se sono scortese, ma quanti anni ha?» chiese l’uomo, che stava seduto timidamente sul cuscino stracciato a gambe incrociate, i gomiti appoggiati sulle ginocchia, sostenendo il mento sul pugno e protendendo il corpo verso di me.
«Ecco… si riferisce a me?»
«Sì. Di sicuro suo marito ha trent’anni, vero?»
«Sì, io ecco… ho quattro anni in meno.»
«Quindi fanno venti…sei. È terribile. No, aspetti, ho fatto bene i conti? Sì dev’essere così. Se suo marito ha trent’anni, è così. Che sorpresa.»
«Ha sorpreso anche me,» disse la donna, sporgendo il viso dall’ombra della schiena del marito. «Sono rimasta stupita. Con una moglie splendida come lei, perché il signor Ōtani è così?»
«È malato. È proprio malato! Prima non era così, ma è peggiorato man mano,» disse l’uomo. Poi fece un forte sospiro.
«A dire il vero, signora,» parlò di nuovo con tono formale, «io e mia moglie gestiamo un piccolo ristorante vicino alla stazione di Nakano. Siamo nati a Jōshū e siamo entrambi rispettabili commercianti, ma ero stanco di fare affari con i contadini spilorci di campagna e vent’anni fa mi trasferii qui a Tōkyō portando con me mia moglie. Iniziammo servendo in un ristorante ad Asakusa, patendo i normali alti e bassi. Ma poi, essendo riusciti a mettere da parte un po’ di soldi – sarà stato nell’anno 1936 – prendemmo in prestito una casa davvero piccola e modesta, con una stanza da sei tatami e una sala, vicino all’attuale stazione di Nakano. Inaugurammo una misera taverna rivolta ai clienti con uno o due yen da spendere per distrarsi. Eravamo intenzionati a lavorare onestamente, senza spese stravaganti, e riuscimmo a immagazzinare un bel po’ di alcolici come shōchū o gin. Così, quando successivamente ci fu quel periodo di carenza di alcolici, non dovemmo cambiare attività come gli altri ristoranti. In un modo o nell’altro, tenemmo duro e riuscimmo a continuare l’attività. Anche i clienti abituali vollero supportare la taverna e ci aiutarono a spianare la strada perché quella ‘corazzata del liquore’ potesse andare avanti un po’ alla volta, arrivando fin qui. Poi cominciò la guerra anglo-americana e, anche se man mano i bombardamenti aerei divennero più violenti, non avendo né bambini né voglia di evacuare verso la campagna, pensammo “Resteremo fino a quando questa casa brucerà” e ci aggrappammo alla nostra attività. In qualche modo la guerra finì senza che noi subissimo danni e ci rasserenammo, potendo ormai vendere apertamente l’alcol che avevamo messo da parte di nascosto.
«Per farla breve, questa è la nostra storia. Tuttavia, raccontandola così, forse potremmo dare l’impressione di essere persone che abbiano vissuto senza particolari problemi e che siano state relativamente fortunate. Ma forse ha ragione colui che dice: “La vita degli esseri umani è un inferno, ne succedono una buona e dieci cattive.” Dietro un momento di felicità, sono sempre appostati dieci diavoli. Se a una persona, in trecentosessantacinque giorni, capita un giorno, anzi, mezzo, in cui non ha niente di cui preoccuparsi, quella è una persona felice. La prima volta che suo marito è venuto al nostro negozio sarà stata la primavera del 1944. A quel tempo la guerra anglo-americana non era ancora una battaglia persa. Anzi no, forse lo stava appena diventando. Ma noi non capivamo i concetti di “essenza” o “verità”. Pensavamo solo che, se in qualche modo fossimo riusciti a resistere per due, tre anni, alla fine avremmo potuto sperare in una riappacificazione equa. Quando il signor Ōtani si presentò al nostro negozio per la prima volta, indossava senza dubbio una giacca invernale informale col tema kurume. Ma non era l’unico: erano poche le persone che camminavano con indosso l’abbigliamento antiaereo, persino a Tōkyō, dove la gente usciva indossando abiti quotidiani senza preoccupazioni. Dunque non pensammo che il signor Ōtani avesse un aspetto trascurato o qualcosa de genere. Non era il solo, a quei tempi. Anche se sono davanti a lei, signora, le dirò tutto senza nascondere nulla: suo marito entrava furtivamente dalla porta di servizio portando con sé una certa donna di mezz’età. Ormai anche noi tenevamo sempre l’ingresso principale chiuso. All’epoca si diceva “negozio chiuso, attività aperta” per descrivere i negozi come il nostro, e solo un piccolo numero di clienti intimi entravano, di nascosto, dalla porta di servizio. Facemmo in modo che i clienti si ubriacassero segretamente non nella sala, ma nello spazio dei sei tatami all’interno, con poca luce e senza alzare la voce. Quella donna di mezz’età lavorava come cameriera in un bar di Shinjuku e portava clienti affidabili alla nostra taverna. Li portava da noi perché, come si suol dire, “conosceva i suoi polli”: il suo appartamento era nelle vicinanze e, da quando il bar di Shinjuku chiuse i battenti e lei smise di fare la cameriera, veniva ancora più spesso con uomini di sua conoscenza. L’alcol cominciò a scarseggiare e, per quanto fossero buoni i clienti, cominciammo a ritenerli non più una benedizione, ma un fastidio. Tuttavia, dato che nei precedenti quattro o cinque anni ci aveva portato un sacco di clienti che spendevano senza ritegno, ci sentivamo in obbligo e decidemmo di continuare a versare da bere alle persone che ci presentava senza battere ciglio. Per questo non avemmo motivo di sospettare quando quella donna, Akichan, portò il signor Ōtani, entrando dalla porta di servizio di soppiatto. Come al solito lo facemmo entrare nella stanza interna e gli versammo dello shōchū. Suo marito quella sera bevve tranquillamente, fece pagare il conto ad Akichan e uscirono insieme dalla porta di servizio. Ma ciò che ci rimase impresso furono i modi stranamente gentili e raffinati di quell’uomo. Magari il diavolo, quando si presenta a casa della gente per la prima volta, appare sempre così mite e innocente. Da quella notte in poi non ci liberammo più di lui. Passati circa dieci giorni, entrò da solo dalla porta di servizio e tirò fuori improvvisamente una banconota da cento yen. A quei tempi cento yen erano una grossa somma, che corrispondeva anche a più di duemila o tremila yen di oggi. Mi strinse la banconota in mano, nonostante le nostre riserve, e disse “Vi prego” sorridendo timidamente. Quella sera aveva bevuto un bel po’, ma lei, signora, lo saprà bene: non esiste persona tanto resistente all’alcol. Quando arriva al punto che sembra essersi ubriacato, inizia improvvisamente discorsi seri e ben articolati e, per quanto beva, non ci ha mai mostrato neanche una volta, per esempio, di non riuscire a reggersi in piedi. Le persone attorno ai trent’anni, essendo all’apice del vigore, reggeranno pure bene l’alcol, ma mai fino a questo punto. Anche quella sera, nonostante avesse consumato già altrove, bevve da noi una decina di bicchieri di shōchū senza una parola e, sebbene noi gli dessimo a parlare, si limitava a sorridere timidamente e ad annuire leggermente mormorando “uhm, uhm”. All’improvviso, alzandosi, chiese “Che ore sono?” e quando gli dissi che dovevo dargli il resto lui lo rifiutò. Gli dissi con insistenza che mi stava mettendo in difficoltà, ma rispose con un sorriso ironico: “Ve li lascio in anticipo per la prossima volta, tornerò ancora,” e se ne andò. Signora, quella fu la prima e l’ultima volta che ricevemmo soldi da lui. Poi, tra una menzogna e l’altra, sono passati tre anni e lui ha prosciugato da solo quasi tutto il nostro alcol senza pagare neanche un soldo. Non è assurdo?»
Scoppiai a ridere involontariamente. Fu strano e inspiegabile, ma mi sentii di colpo sopraffatta. Mi coprii frettolosamente la bocca e, quando la guardai, anche la signora sorrise leggermente abbassando la testa. Poi l’uomo, sorridendo con rassegnazione, continuò:
«Non ci sarebbe nulla da ridere, ma è così assurdo che anche a me viene di farlo. A dire il vero, se usasse una simile abilità in modo più onesto, potrebbe diventare qualsiasi cosa, anche un ministro o uno studioso. Quell’uomo non ha preso di mira soltanto noi due: ci sono anche altre persone finite sul lastrico che stanno piangendo sotto questo freddo cielo. Per esempio Akichan, che per il signor Ōtani ha finito per farsi scappare un buon partito ed è rimasta senza soldi e senza abiti. Adesso pare stia facendo la vita della mendicante in una stanza fetida in una casetta a schiera. Ma a dire il vero, quella Akichan, nel periodo in cui aveva conosciuto il signor Ōtani, si era disgraziatamente infatuata e si pavoneggiava anche davanti a noi. “Innanzitutto è di classe sociale alta. È il secondogenito di un certo barone Ōtani, di un ramo familiare di un signore feudale dello Shikoku, e adesso è stato diseredato per cattiva condotta. Ma se suo padre, il barone, dovesse morire, dividerebbe il patrimonio con il suo fratello maggiore. È intelligente, quello che si direbbe un genio. A ventun’anni ha scritto un libro, migliore perfino dell’opera scritta da quel talento di nome Takuboku Ishigawa, e d’ora in avanti scriverà un’altra decina di libri. Nonostante sia ancora giovane, sta diventando il poeta numero uno in Giappone. Ed è un grande studioso: viene dalla Gakushūin, l’università imperiale, e sa il tedesco, il francese… È incredibile.” Qualsiasi cosa Akichan dicesse, quell’uomo somigliava in tutto a un dio. Ma sembra non fossero tutte bugie. Ascoltando anche altre persone, abbiamo avuto riscontri sul fatto che sia il secondogenito di un barone Ōtani e che sia un famoso poeta. Così persino mia moglie, nonostante abbia l’età per saperne abbastanza del mondo, si invaghì e prese a concorrere con Akichan. Mi parlava di come si vede davvero la differenza quando una persona è di buona famiglia, e mi era diventato insopportabile che lei aspettasse con tanta impazienza il suo arrivo. Ormai oggigiorno pare che la nobiltà stia scomparendo, ma fino alla fine della guerra niente aveva effetto sulle donne come un giovane nobile diseredato. Le donne ne sembravano ammaliate. Sarà per quello che oggigiorno chiamano “carattere servile”. Io non credo che la posizione di un uomo come me sia in qualche modo diversa rispetto a quella di un uomo proveniente da famiglia nobile, o meglio – e mi perdoni se lo dico davanti a lei – di un ramo di un signorotto dello Shikoku, e per di più secondogenito. Non sono mai rimasto ammaliato in quel modo tanto miserevole.
«Ciononostante, in fin dei conti quell’uomo è un punto debole anche per me. Per quanto fermamente io sia determinato a non dargli da bere, quando arriva a un’ora inaspettata e gli vedo sul volto un’espressione sollevata nel varcare la soglia, come se l’avessero inseguito, puntualmente la mia risoluzione crolla all’istante e finisco per versargli il liquore. Non è chiassoso neanche da ubriaco e se pagasse il conto sarebbe anche un buon cliente. Non mette in mostra la sua posizione, né s’è mai vantato scioccamente di essere un genio o cose del genere. E quando, per esempio, Akichan al suo fianco pubblicizzava la sua grandezza davanti a tutti, lui cambiava argomento e gelava l’atmosfera dicendo “Avrei bisogno di soldi, devo pagare il conto.” Fino a ora non ha mai pagato ciò che ha bevuto, ma di tanto in tanto Akichan ha pagato per lui. C’era anche una donna segreta, che lui sembrava tener nascosta ad Akichan, e che veniva ogni tanto con lui, come una moglie uscita da chissà dove. Questa donna lasciava generose quantità di denaro al posto suo. Ma succedeva raramente, e noi che siamo commercianti non potevamo continuare a farlo bere gratuitamente per sempre, che fosse il maestro Ōtani o il principe imperiale in persona. Quei conti pagati di tanto in tanto non erano certamente sufficienti e quel debito era per noi una grande perdita. Abbiamo sentito dire che il maestro aveva una casa a Koganei e che aveva anche moglie e quindi, pensando che saremmo potuto andare una volta lì a parlare del conto in sospeso, abbiamo provato a chiedere al signor Ōtani indirettamente dove fosse casa sua. Lui subito sospettò che stessimo tramando qualcosa e disse cose spiacevoli come “Non posso darvi ciò che non ho, perché tutta quest’ansia? Non sarebbe bello se dovessimo litigare.” Ciononostante volevo scoprire dove abitasse e provai a seguirlo due o tre volte, ma ogni volta riusciva ad aggirarmi abilmente. Nel frattempo i raid aerei su Tōkyō divennero continui e il signor Ōtani a volte veniva saltando, con in testa un berretto militare, prendeva senza chiedere una bottiglia di brandy dal mobile, la tracannava ancora in piedi e sfrecciava via come il vento. Infine la guerra terminò e noi potemmo rifornirci apertamente di liquori. Esponemmo una nuova insegna sulla facciata del negozio e in qualche modo il negozio, seppur povero, era frequentato, quindi assumemmo una bella ragazza che servisse i clienti. Ma quel diavolo si mostrava ancora, questa volta non con delle donne, ma veniva puntualmente con due o tre scrittori di articoli per giornali e riviste, inventavano discorsi come su un tale soldato che, dopo la resa, aveva vissuto finora da poeta straccione e che adesso veniva elogiato da tutti, e il maestro Ōtani diceva loro qualcosa di incomprensibile, come il nome di un qualche straniero, forse inglese, forse un filosofo, per poi alzarsi con disinvoltura, uscire fuori e non tornare. Allora i giornalisti, con espressione basita, dicevano “Dove diavolo è andato quello? Che facciamo, ce ne andiamo?” e cominciavano a prepararsi per andarsene, ma io dicevo loro “Aspettate per favore. Il maestro usa sempre questo trucco e scappa. Il conto dovreste pagarlo voi.” C’erano persone che raccoglievano i soldi e pagavano con tranquillità, ma anche persone che si arrabbiavano e dicevano “Noi, con cinquecento yen, ci dobbiamo campare!” Si infuriavano, ma nel momento in cui io dicevo loro “Ma voi sapete a quanto ammonta finora il debito del signor Ōtani? Se voi riusciste a fargli cacciare i soldi, non importa quanto, ve ne darei la metà.” Loro facevano una faccia infastidita, “Ma guarda un po’, non avrei mai pensato che Ōtani fosse un simile bastardo. D’ora in poi, non berremo mai più con quello lì. Stasera non abbiamo neanche cento yen. Ve li portiamo domani. Nel frattempo, prendete questo in permuta,” e per esempio si toglievano il cappotto. In giro si dice che i giornalisti siano persone maleducate, ma, paragonati al signor Ōtani, appaiono come onesti e modesti. Se lui è il secondogenito di un barone, allora i giornalisti valgono quanto il primogenito di un principe. Il signor Ōtani aveva cominciato a bere ancora di più da quando la guerra era finita, i suoi lineamenti divennero più duri, si lasciava sfuggire battutacce volgari che fino ad allora non erano mai uscite dalla sua bocca e magari colpiva il giornalista con cui era venuto, dando inizio a una rissa. Inoltre, prima ancora che ce ne potessimo accorgere, aveva sedotto la ragazza, non ancora ventenne, che lavorava per noi. Rimanemmo scioccati e imbarazzati. Ma ormai il danno era fatto e non potemmo fare altro che accettare la situazione, persuadere la ragazza a rassegnarsi e la rimandammo segretamente dai genitori. Quando lo pregai “Signor Ōtani, la prego, non venga più,” mi rispose minaccioso “Chi ha guadagnato col mercato nero non dovrebbe permettersi di aprire bocca. Io so tutto!” Ma poi la sera successiva aveva di nuovo un volto sereno. Abbiamo pensato che forse avremmo dovuto accettare questo mostro come punizione per il mercato illegale che abbiamo condotto durante la guerra. Tuttavia, una cosa tremenda come quella che ha fatto questa sera non la si può giustificare dicendo che è un poeta o un maestro. È un ladro. Ci ha rubato cinquemila yen ed è fuggito. Di solito in casa abbiamo massimo cinquecento o mille yen in contanti, dato che usiamo tutto il resto per i rifornimenti. A essere sinceri, i soldi guadagnati dalle vendite, come arrivano, così se ne vanno. Se questa notte avevamo in casa cinquemila yen è solo perché si sta avvicinando la fine dell’anno e siamo andati in giro, casa per casa dei nostri clienti abituali, a riscuotere i conti in sospeso. Se non li versiamo subito per i rifornimenti, dal prossimo capodanno non potremo continuare la nostra attività. Perciò quei soldi sono così importanti. Mia moglie stava facendo i conti nella stanza interna e li ha messi nel cassetto di un mobile. Lui, vedendo ciò mentre beveva da solo, seduto su una sedia nella sala, si è alzato di scatto, è entrato con determinazione nella stanza e, senza dire nulla, ha spinto da parte mia moglie, ha aperto il cassetto, ha afferrato il rotolo di banconote e se l’è infilato nel portafogli. Mentre noi eravamo ancora presi alla sprovvista, è uscito velocemente dalla stanza e dal negozio. Ho cominciato a chiamarlo a gran voce e insieme a mia moglie l’ho inseguito. Stavo per urlare «Al ladro!» per attirare la gente che passava per di là, ma poi ho pensato che, dopotutto, il signor Ōtani era un nostro vecchio conoscente e che sarebbe stato crudele. Questa notte, costi che quel costi, l’avrei seguito senza perderlo di vista e, una volta che gli spiriti si fossero calmati, gli avrei chiesto con tranquillità di restituirmi il denaro. Siamo solo dei miseri commercianti, abbiamo unito le nostre forze per arrivare infine a questa casa, abbiamo chiesto di restituirci i soldi tenendo a bada il nostro rancore e lui cosa fa? Caccia il pugnale e dice “Vi accoltello!” Mah, incredibile!»
Ancora una volta fui assalita dalla ridicola assurdità della cosa e scoppiai inspiegabilmente a ridere con forza. La signora si fece rossa in viso e sorrise un po’. Pur realizzando che era cattiva educazione, non riuscivo a smettere di ridere: era tutto così ridicolo che continuai a ridere a lungo fino a farmi uscire le lacrime dagli occhi. All’improvviso mi chiesi se non fosse ciò che mio marito intendeva, in una delle sue poesie, con “La grande risata alla fine della civiltà.”
II
Tuttavia, non era una questione che si poteva risolvere con una gran risata. Ci riflettei sopra e mi rivolsi ai due ospiti: «Dunque, io farò qualcosa e risolverò il problema, se voi poteste aspettare un giorno soltanto per andare dalla polizia. Vi farò visita domani,» e mi feci spiegare precisamente l’ubicazione del loro negozio a Nakano e pregai loro insistentemente perché acconsentissero. Quella notte si ritirarono e rimasi da sola, seduta al centro della fredda stanza da sei tatami in preda all’ansia; tuttavia, dal momento che non mi veniva in mente alcun piano in particolare, mi alzai, mi tolsi lo haori2 e mi infilai nel futon dove stava dormendo il bimbo. Mentre accarezzavo la sua piccola testa, pensavo che sarebbe stato bello se quella notte fosse durata per sempre. Per sempre.
Tempo fa mio padre aveva una bancarella di oden vicino lo stagno Hyōtan’ike del parco di Asakusa. La mamma morì presto, io e mio padre vivevamo da soli in una casetta a schiera e gestivamo l’attività da soli. Quell’uomo, colui che sarebbe diventato mio marito, ogni tanto veniva alla bancarella. Io ingannavo mio padre e mi incontravo di nascosto con lui; poiché rimasi incinta, per risolvere il problema, decidemmo che mi sarei presentata come sua moglie, anche se chiaramente non eravamo registrati. Il bimbo era cresciuto come se non avesse un padre, mentre quell’uomo restava fuori casa per tre o quattro sere. Anzi, capitava che passasse anche un mese senza tornare a casa, per fare chissà cosa e chissà dove, e quando tornava era sempre ubriaco fradicio e col volto livido. Ansimando in maniera sofferente guardava in silenzio il mio viso, a volte versando fiumi di lacrime, e poi improvvisamente si infilava nel futon in cui dormivo e, abbracciandomi con forza, diceva cose come: «Ah, non posso andare avanti così. Ho paura. Ho paura. Io ho paura! Aiutami!» A volte tremava violentemente e, anche dopo essersi addormentato, parlava in delirio oppure gemeva. Poi la mattina successiva restava assente, come un uomo senz’anima, e all’improvviso scompariva senza far ritorno a casa per tre o quattro notti. Di tanto in tanto un paio di persone, vecchi conoscenti di mio marito che lavorano nell’editoria, si davano pensiero per la nostra situazione e venivano a portarci del denaro. Così in qualche modo io e il bimbo siamo riusciti a sopravvivere fino a quel momento senza morire di fame.
Mi appisolai, poi, quando aprii gli occhi all’improvviso, dalle crepe della finestra mi accorsi che filtravano i raggi del mattino. Mi alzai, mi vestii, annodai il bimbo dietro la mia schiena e uscii. Non ce la facevo più a stare in silenzio in casa.
Senza sapere dove andare, mi diressi verso la stazione. Comprai una caramella da una bancarella di fronte la stazione e la feci mangiare al bimbo. Poi d’un tratto mi venne in mente una cosa: comprai un biglietto per Kichijōji e salii sul treno. Tenendomi alla maniglia sospesa, guardavo con indifferenza i cartelloni che pendevano dal soffitto della carrozza, quando balzò davanti ai miei occhi il nome di mio marito. Era la pubblicità di una rivista in cui aveva pubblicato un lungo lavoro dal titolo “Françoise Villon”. Mentre fissavo il nome di mio marito e quello di Françoise Villon, non so perché, cominciai a versare una cascata di lacrime amare, tante da non riuscire più a vedere la locandina.
Scesi a Kichijōji e volli camminare per il parco di Inokashira per la prima volta in non so quanti anni. I cipressi sulla sponda dello stagno erano stati completamente troncati, così il parco dava uno strano senso di fredda nudità, come se fosse un terreno su cui avessero iniziato dei lavori. Era completamente cambiato rispetto a un tempo.
Feci scendere il mio bambino dalla schiena, ci sedemmo su una panchina sgangherata in riva allo stagno uno accanto all’altra e gli feci mangiare una patata dolce che avevo portato da casa.
«Piccolo, è un bel lago, vero? Un tempo era pieno di carpe e pesci rossi. Ma ora non ce ne sono proprio più. Che peccato.»
«Ke ke ke,» il bimbo, pensando a chissà cosa, fece una strana risatina, con la bocca ancora piena per la patata. Era mio figlio, ma a volte mi dava la sensazione di essere un idiota.
Standomene seduta su quella panchina in riva al lago non avrei risolto nulla, quindi mi legai di nuovo il bambino sulla schiena e tornai indietro verso la stazione di Kichijōji ciondolando, girando per le strade animate piene di bancarelle. Poi alla stazione comprai un biglietto per Nakano, senza un’idea o un piano, e, come se fossi risucchiata, per così dire, in uno spaventoso pozzo maledetto, scesi dal treno a Nakano, camminai per la strada che mi era stata spiegata il giorno prima e giunsi davanti alla piccola taverna di quell’anziana coppia.
La porta sul fronte non si apriva, quindi andai sul retro ed entrai dalla porta di servizio. Il proprietario non c’era e la moglie puliva da sola il negozio. Nel momento in cui incontrai il suo sguardo, cominciai a dirle delle bugie che sorpresero anche me stessa.
«Ecco, signora, sembra che riuscirò a restituirvi tutti i soldi. Forse stasera, al massimo domani. In ogni caso non preoccupatevi, è tutto sistemato.»
«Oh, bene. Grazie.» disse la signora, con un’espressione che sembrava un po’ felice, ma che conservava da qualche parte un’ombra di apprensione, come se non fosse convinta.
«Signora, dico sul serio. Li porterà una persona. Io nel frattempo resterò tutto il tempo qui come ostaggio. È più tranquilla così? Posso anche dare una mano nel negozio, finché i soldi non arrivano.»
Feci scendere il bimbo dalla mia schiena e lo lasciai a giocare da solo nella stanza interna. Era abituato a giocare da solo e non si lamentò affatto. Forse sarà perché un po’ stupido, ma non aveva paura degli estranei e sorrideva anche alla padrona della locanda. Mentre io ero andata a fare la spesa per conto della signora, pare che il piccolo fosse rimasto tranquillo in un angolo della stanza a giocare con delle lattine americane vuote che lei gli aveva dato come giocattoli, sbattendole l’una contro l’altra e facendole rotolare sul pavimento.
Il signore ritornò verso mezzogiorno, con le scorte di pesce e verdure. Quando incontrai il suo volto, ripetei ancora una volta, parlando veloce, le stesse bugie che avevo detto alla moglie.
Sembrò sbalordito.
«Davvero? Però, signora, quando si tratta di soldi, non si è mai sicuri finché non li si stringe nelle proprie mani!» disse con tono di spiegazione inaspettatamente tranquillo.
«No, vi assicuro che è vero! Perciò abbiate fiducia in me e aspettate un giorno prima di fare la denuncia. Io nel frattempo aiuterò nel negozio.»
«Se il denaro verrà restituito, non ce ne sarà bisogno,» disse il signore, come parlando da solo. «Comunque sia, mancano ancora cinque, sei giorni alla fine dell’anno.»
«Sì, appunto, quindi io… Oh, dei clienti! Benvenuti!» Accolsi sorridendo la compagnia di tre persone – dall’aspetto sembravano dei lavoratori – che era entrata nel negozio. Poi chiesi sussurrando «Per favore, signora, mi presti un grembiule.»
«Ehi, avete assunto proprio una bellezza. Questa donna è fantastica,» disse uno dei clienti.
«Non tentatela, per favore,» disse il padrone, con un tono che suonava per niente come uno scherzo, «costa un sacco di soldi.»
«Una cavalla di razza da un milione di dollari?» scherzò con volgarità un altro cliente.
«Anche nel caso dei cavalli di razza, pare che le femmine costino la metà,» risposi in modo altrettanto volgare mentre riscaldavo il sake.
«Non fare la modesta. D’ora in poi in Giappone ci sarà parità tra i sessi, anche tra cavalli e tra cani,» disse, quasi gridando, il cliente più giovane. «Signorina, mi sono innamorato. È stato amore a prima vista. Ma dimmi, quello è tuo figlio?»
«No,» la signora uscì dalla stanza interna portando in braccio il bambino, «ce l’hanno affidato dei nostri parenti. In questo modo, finalmente anche noi abbiamo un erede.»
«E avrete ricevuto anche dei soldi,» uno dei clienti lo canzonava.
Allora il padrone della locanda mormorò:
«E scappatelle, e debiti.» Poi, cambiando all’improvviso il tono di voce, chiese, «Cosa prendete? Che ne dite di un nabe3?»
Quella volta compresi una cosa. Ah, è così, pensai tra me e me, ma con apparente disinvoltura portai la fiaschetta di sake ai clienti.
Era la vigilia di Natale e quella notte i clienti non diminuivano mai, arrivavano in continuazione. Non avevo mangiato nulla dalla mattina, ma il mio stomaco era sazio di preoccupazioni e rifiutai anche quando la signora mi disse di mangiare qualcosa. Andavo solo avanti e indietro, volteggiando come se indossassi un mantello di piume. Forse sarà stata vanità, ma quella sera il ristorante sembrava così vitale e c’erano un bel po’ di clienti che vollero sapere il mio nome o stringermi la mano.
Tuttavia, non avevo idea di cosa sarebbe successo dopo. Non facevo che sorridere, rispondere a tono alle battute sconce dei clienti, i quali rispondevano a loro volta con battute ancora più volgari, e scivolavo da un cliente all’altro versando liquori, mentre pensavo solamente che sarebbe stato bello se il mio corpo si fosse sciolto come un gelato.
A volte, in questo mondo, i miracoli accadono davvero.
Saranno state le nove passate da poco. Vidi entrare due clienti: un uomo, il quale indossava un copricapo natalizio di carta a tre punte e una maschera nera che gli copriva metà volto come Lupin, e una bella donna snella, che avrà avuto trentaquattro o trentacinque anni.
L’uomo si sedette su una sedia in un angolo dandomi le spalle, ma nel momento stesso in cui era entrato nella locanda avevo già capito chi fosse. Quel ladro di mio marito.
Dato che si comportava come se non si accorgesse di me, anch’io feci finta di niente e scherzavo con gli altri clienti, quando la donna, che era seduta di fronte a lui, mi chiamò:
«Signorina, mi scusi.»
«Eccomi,» risposi e, avvicinatami al loro tavolo, dissi loro: «Benvenuti. Vi porto qualcosa da bere?» In quel momento mio marito, dietro la sua maschera, mi vide e come previsto rimase sbalordito. Ma io sfiorai leggermente la sua spalla e dissi:
«Non mi fai gli auguri di Natale? Che cosa dici? Sembra che hai già bevuto un paio di bottiglie.»
La donna ignorò le mie parole e mi disse con espressione formale:
«Mi scusi, signorina. Vorrei parlare in privato col proprietario di questo posto. Potrebbe andare a chiamarlo?»
Andai nel retro, dove il padrone stava preparando le fritture.
«Ōtani è tornato. Andate a incontrarlo. Però non dica nulla di me davanti a quella donna. Non voglio metterlo in una situazione imbarazzante.»
«Alla fine è venuto, eh?»
Poiché il padrone, pur avendo in parte dei sospetti sulla mia bugia, riponeva abbastanza fiducia in me, sembrò comprendere con semplicità quella mia richiesta.
«Non dica nulla di me, mi raccomando,» ripetei.
«Se è quel che desidera, così sia,» acconsentì con franchezza e andò nella sala.
Diede uno sguardo ai clienti in sala, poi si avvicinò, camminando diritto, al tavolo dove era seduto mio marito. Scambiò due o tre parole con la bella donna, poi i tre uscirono dalla taverna.
È tutto a posto, tutto è stato sistemato, ero in qualche modo sicura. Mi sentivo davvero felice, strinsi improvvisamente il polso di una giovane cliente, non ancora ventenne, con indosso un kimono blu scuro, e le dissi:
«Beviamo! Dai, beviamo! È Natale!»
III
Dopo solo trenta minuti, anzi, ancora prima – prima di quanto pensassi – il padrone della locanda ritornò da solo e venne al mio fianco:
«Signorina, grazie mille. Ho riavuto i miei soldi.»
«Ne sono felice. Tutti?»
Sorrise in modo singolare. «No, solo i soldi di ieri.»
«E quanto sarebbero i debiti in totale? Approssimativamente, cioè, come minimo.»
«Ventimila yen.»
«Sarebbero sufficienti?»
«Come minimo.»
«Ve li restituirò. Signore, mi farebbe lavorare per voi da domani? Vi ripagherò lavorando.»
«Cosa? Signorina, sta scherzando!» e scoppiamo a ridere insieme.
Quella notte lasciai la locanda di Nakano dopo le dieci, mi caricai il bimbo sulle spalle e tornai alla nostra casa di Koganei. Come pensavo, mio marito non era tornato a casa, ma mi sentivo tranquilla comunque. Potrei incontrarlo domani alla locanda. Chissà perché fino a ora non ho mai avuto questa bella idea. Tutte le mie sofferenze, fino a ieri, sono state colpa della mia stupidità, perché non ho avuto buone idee del genere. Io, che tempo fa non ero affatto male a ricevere i clienti alla bancarella di mio padre, di sicuro me la caverò più che bene in quella taverna a Nakano. Stasera ho avuto quasi cinquecento yen di mance.
Stando a quanto aveva detto il locandiere, mio marito la notte precedente aveva dormito a casa di un conoscente, poi quella mattina presto aveva fatto irruzione nel bar di Kyōbashi dove lavorava quella bella donna, aveva bevuto whisky dalla mattina, poi aveva dato dei soldi a cinque ragazze che lavoravano in quel posto, dicendo che si trattava di un regalo di Natale; verso mezzogiorno aveva chiamato un taxi ed era andato da qualche parte, dove si era fermato per un po’; poi era venuto portando con sé il cappello natalizio a tre punte, la maschera, una torta decorativa e persino un tacchino, aveva fatto delle telefonate qua e là, aveva radunato vari conoscenti, aveva tenuto un banchetto con persone che non avevano mai un soldo in tasca; la donna aveva cominciato ad avere dei dubbi, gli aveva chiesto spiegazioni e mio marito le aveva detto di stare tranquilla e le aveva raccontato i fatti della notte precedente, ma poiché lei, che conosceva da tempo mio marito, gli aveva detto con premura che sarebbe stata una bella scocciatura se fosse coinvolta la polizia, aveva deciso di anticipargli i soldi e aveva condotto mio marito alla taverna di Nakano. Il padrone si volse verso di me:
«Più o meno avevo immaginato che sarebbe potuto succedere. Ma lei, signorina, sapeva tutto per filo e per segno, eh? Avrà chiesto anche agli amici del signor Ōtani.»
Sin dall’inizio avevo parlato come se avessi previsto che sarebbe tornato e che lo stessi aspettando al locale. Sorrisi e risposi solamente:
«Diciamo di sì.»
Dal giorno seguente la mia vita cambiò completamente e divenne spensierata e allegra. Per prima cosa andai a fare una permanente e mi feci tagliare i capelli, mi rifornii di trucchi, feci ricucire i vestiti. La signora mi donò anche un paio di calzini nuovi. Avevo la sensazione che i pensieri opprimenti che avevo nel cuore fino a quel momento fossero stati spazzati via del tutto.
Di mattina io e il bimbo ci svegliavamo e mangiamo la colazione. Poi preparavo i bentō4, mi legavo il piccolo sulla schiena e andavo a lavoro a Nakano. Ero diventata per tutti “Sacchan della taverna Tsubakiya”. Ma essendo il periodo di capodanno, momento di grandi affari per il negozio, ero sempre così impegnata da far girare gli occhi. Una volta ogni paio di giorni mio marito veniva a bere qualcosa, faceva pagare a me il conto, poi scompariva ancora. La notte tardi si affacciava nel negozio e diceva piano:
«Torniamo a casa?»
Io annuivo, mi preparavo e spesso facevamo la strada di casa in modo lieto.
«Perché non abbiamo fatto così sin dall’inizio? Sono davvero felice!»
«Le donne non sanno nulla della felicità e dell’infelicità.»
«Sul serio? Ora che me lo dici, forse è così. E allora gli uomini?»
«Per gli uomini esiste solo l’infelicità. Non fanno che combattere col terrore.»
«Non lo capisco, io. So solo che continuerei a vivere così per sempre. Il nonnino e la nonnina dello Tsubakiya sono delle persone molto buone.»
«Sono degli idioti, quei due. Dei bifolchi avari. Pensano che, facendomi bere, alla fine ne guadagneranno qualcosa.»
«È ovvio, è il commercio. Però non è solo questo, vero? Hai insidiato la signora, vero?»
«È stato tempo fa. Il vecchio l’ha capito?»
«Lo sa bene. Ha detto sospirando che da te hanno avuto scappatelle e debiti.»
«Anche se posso sembrare affettato, non posso fare altro che desiderare di morire. Non penso ad altro da quando sono nato. Sarebbe meglio se morissi, per il bene di tutti. Questo è poco ma sicuro. E nonostante tutto non riesco proprio a morire. Qualcosa come uno strano, spaventoso Dio ostacola la mia morte.»
«È perché hai il tuo lavoro.»
«Il mio lavoro non significa nulla. Non creo né capolavori né fiaschi. Se la gente dice che un’opera è buona, allora è buona; se dice che è cattiva, allora è cattiva. È come espirare nel momento in cui si inspira. La cosa spaventosa è che nel mondo possa esistere un Dio. Esiste, non è vero?»
«Eh?»
«Esiste, vero?»
«Non lo so.»
«Ecco.»
Nei dieci, venti giorni in cui avevo frequentato la taverna, mi ero resa conto che i clienti che venivano a bere alcolici allo Tsubakiya erano tutti, nessuno escluso, criminali. Cominciai a pensare che, paragonato a loro, mio marito fosse piuttosto una persona gentile. Ma non solo i clienti della locanda: tutte le persone che camminavano per quella strada mi facevano pensare che avessero qualche crimine disonesto che volevano nascondere a ogni costo. Una signora elegante sulla cinquantina venne a vendere del liquore alla porta di servizio dello Tsubakiya a trecento yen a bottiglia. Essendo più economico dell’attuale prezzo di mercato, la padrona lo comprò immediatamente, ma era liquore annacquato. In un mondo in cui persino una signora così raffinata arriva ad architettare una simile cosa, mi viene da pensare che sia impossibile condurre una vita senza una macchia di disonestà. Come in quel gioco di carte in cui se si raccolgono tutte le carte negative esse diventano positive, non è possibile che lo stesso possa succedere anche con la morale di questo mondo?
Dio, se esisti, vieni fuori!
Alla fine del periodo di Capodanno, venni violata da un cliente.
Quella notte pioveva. Mio marito non si era presentato, ma vennero a bere due persone: Satō, il conoscente di mio marito che lavorava nell’editoria che di tanto in tanto mi aveva portato dei soldi per vivere, e un altro uomo che sembrava dello stesso settore e che avesse anche la sua stessa età, sulla quarantina. I due parlavano ad alta voce, con tono che sembrava per metà scherzoso, discutendo se fosse appropriato o meno che la moglie di Ōtani lavorasse in un simile posto. Sorridendo, chiesi loro:
«E dove si trova questa signora?»
«Non so dove sia. Ma come minimo è più bella e raffinata di Sacchan dello Tsubakiya,» disse Satō.
«Che invidia. Vorrei proprio passare anche una sola notte col signor Ōtani. Mi piacciono le persone scaltre come lui,» risposi.
«Vero, eh?» e il signor Satō girò il volto verso il suo compagno e storse la bocca.
A quel punto, anche i giornalisti che venivano insieme a mio marito sapevano che ero la moglie del poeta chiamato Ōtani, ma c’erano anche persone curiose che me lo chiedevano apposta per prendermi in giro. Col locale che diventava vivace, mi abituai sempre più anche all’ironia del padrone.
Quella notte, anche Satō e il collega se ne erano andati, discutendo di qualche affare sporco, fuori pioveva e mi sembrava improbabile che mio marito si facesse vedere. Allora, nonostante fosse rimasto ancora un cliente, cominciai a prepararmi per tornare, mi caricai sulle spalle il bimbo che dormiva in un angolo della stanza sul retro e chiesi alla padrona:
«Posso prendere in prestito un ombrello?»
«Io ho un ombrello. La accompagno,» disse il cliente che era rimasto, dall’aspetto di un operaio, magro e basso, di venticinque o ventisei anni. Era la prima volta che lo vedevo.
«Grazie per la sua gentilezza, ma sono solita tornarmene da sola.»
«Ma no, abita lontano. Io lo so, anche io abito a Koganei, nello stesso vicinato. La accompagno. Nonnina, il conto!»
Aveva bevuto solo tre bottiglie e non sembrava particolarmente ubriaco.
Prendemmo il treno insieme, scendemmo a Koganei, poi camminammo sotto la pioggia per una strada buia, una accanto all’altro sotto lo stesso ombrello. Il giovane non aveva quasi per niente aperto bocca, ma cominciò a parlare un po’ alla volta:
«Io sono un ammiratore delle poesie del maestro Ōtani. Anch’io scrivo poesie. Volevo mostrarle al maestro, ma lui mi spaventa.»
Raggiungemmo casa.
«Grazie mille. Arrivederla alla taverna.»
«Arrivederci.» Il giovane se ne andrò sotto la pioggia.
A notte fonda mi svegliai perché sentii un fracasso dall’ingresso, ma, pensando che fosse di nuovo mio marito che rincasava sbronzo, rimasi stesa in silenzio.
«Mi scusi. Signora Ōtani, mi scusi.» Arrivò una voce da uomo.
«Signora, mi scusi. Tornando a casa ho bevuto ancora in un chioschetto. A dire il vero la mia casa è a Tachigawa e, se anche andassi alla stazione, non ci sarebbero più treni. Signora, glielo chiedo per favore: mi faccia dormire qui. Non c’è bisogno neanche del futon. Va bene anche a terra qui nell’ingresso. Mi faccia restare fino al primo treno di domattina. Dormirei fuori nei paraggi, sotto qualche grondaia, ma con questa pioggia è impossibile. Per favore.»
«Mio marito non c’è, ma se le va bene il pavimento dell’ingresso, faccia pure,» dissi e posai sul pavimento due cuscinetti lisi.
«Grazie. Ah, sono sbronzo.» Disse con voce affaticata e subito si stese nell’ingresso così com’era. Nel momento in cui ritornai a letto, sentii già un forte russare.
Poi, appena venne il giorno seguente, quell’uomo mi prese senza che potessi fare nulla.
Quel giorno presi il bimbo e andai a lavorare, comportandomi come se non fosse successo nulla.
Mio marito era nella sala della taverna, il bicchiere pieno di liquore sul tavolo, e leggeva da solo il giornale. Pensai che il bicchiere, attraversato dalla luce del mattino, fosse davvero bello.
«Non c’è nessuno?»
Mio marito si girò verso di me:
«No. Il vecchio è uscito a fare rifornimenti e non è ancora tornato; la vecchia era nel retro fino a un attimo fa. Adesso non c’è?»
«Stanotte non sei venuto?»
«Sono venuto. Non riesco a dormire se non vedo la faccia di Sacchan dello Tsubakiya. Quando mi sono affacciato dopo le dieci, mi hanno detto che eri appena andata via.»
«E poi?»
«Mi sono addormentato. Proprio qui. Pioveva a dirotto.»
«Forse da ora in poi potrei dormire qui in negozio.»
«È una buona idea.»
«Allora facciamo così. Non ha senso pagare ancora l’affitto di quella casa.»
Mio marito posò gli occhi di nuovo sul giornale in silenzio.
«Ah, scrivono ancora brutte cose di me. “Un aristocratico che si fa passare per epicureista.” Questo tizio ha sbagliato. Sarebbe stato meglio se mi avesse chiamato “un epicureista terrorizzato da Dio”. Sacchan, guarda. Qui c’è scritto che sono disumano. Non è vero. Te lo dico solo ora, ma quando portai via da qui quei cinquemila yen, volevo usarli per far passare a te e al bambino un felice capodanno come non ne abbiamo mai avuti. Se fossi disumano, non avrei fatto una cosa del genere.»
Non ne fui particolarmente felice. Dissi:
«Va bene anche essere disumani, finché siamo ancora vivi.»
1 Sandali infradito giapponesi con suola di legno rialzata.
2 Soprabito tradizionale giapponese.
3 Stufato di ingredienti misti (verdure, carne, pesce) cucinato dagli stessi clienti in una pentola (chiamata appunto “nabe”) posta al centro del tavolo.
4 Pasti da asporto in contenitori con coperchio, solitamente divisi all’interno in diverse sezioni.
Dazai Osamu 太宰 治, pseudonimo di Tsushima Shūji; Kanagi, 19 giugno 1909 – Tokyo, 13 giugno 1948.




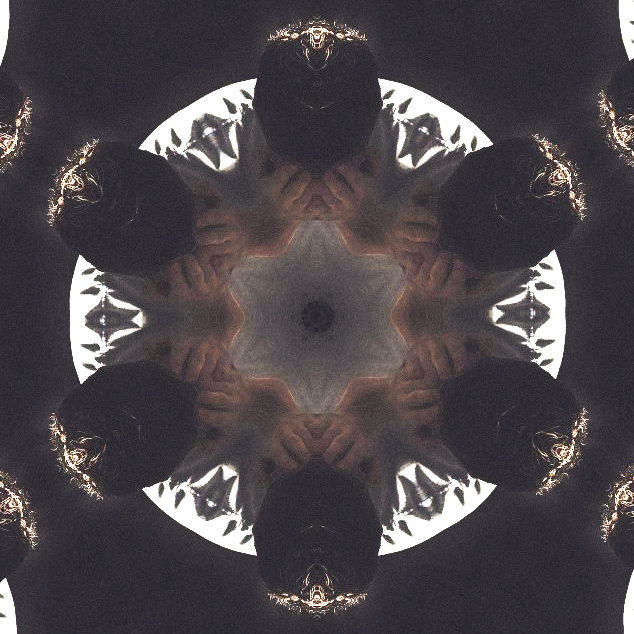
1 Commento
Unisciti alla discussione per dirci la tua
[…] Dazai ha scritto un racconto, La moglie di Villon, su cui aleggia lo spirito del mio poeta maledetto (ante litteram) preferito. Un racconto che non […]